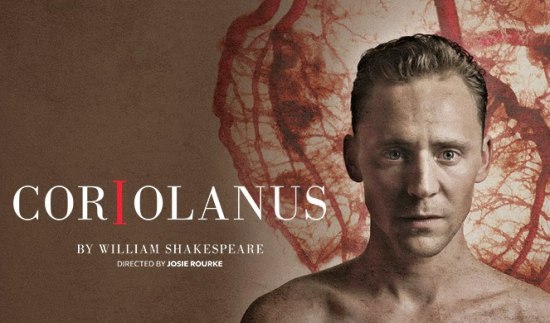Di Stanley Cavell
Una versione del presente saggio fu inviata alla professoressa Janet Adelman in occasione di un convegno su Shakespeare, da lei organizzato, da tenersi a Stratford-upon-Avon nel 1981. Io non fui in grado di prender parte a quel Congresso e, quindi, alle discussioni che vi ebbero luogo; ma trassi da esse profitto per un successivo convegno svoltosi presso The Humanities Institute della Stanford University nel settembre 1982. La presente versione è stata curata per esser pubblicata su Representations nel 1983.Il postscriptum invece è stato scritto in epoca successiva.
da Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali
Università di Roma “La Sapienza”, link non più attivo
(Coriolanus and interpretations of politics) (“Chi è che il lupo ama?”)
“Non è la prima volta che qualcuno afferma che le opere di Shakespeare non sono state scritte dall’uomo di Stratford”, inizia così il saggio di Tassinari. Ma se non è la prima volta che si avanzano nomi sulla vera identità del cosiddetto “Shakespeare” (“Anti-Stratfordians” sono chiamati i critici scettici, in opposizione ai “Stratfordians”, sostenitori dello Shakespeare ortodosso), è la prima volta che uno studioso apporta a questo tormentoso tema della paternità letteraria di “Hamlet” e degli altri capolavori teatrali attribuiti all’uomo di Stratford uno sguardo così profondo e una così ricca messe di nuove ipotesi e argomentazioni, sostenute da un apparato di citazioni e di note, in un libro che è avvincente e godibile grazie anche ad una magnifica lingua, ricca e chiara, così lontana dallo stile farraginoso e ostentatamente dotto di tanti scritti italiani di critica.
Nel corso degli anni sono stati proposti diversi nomi – “sessanta i candidati” ci fa sapere Tassinari – per tentare di risolvere quello che tantissimi studiosi considerano il “mistero Shakespeare”, ossia il mistero della vera paternità di una creazione teatrale gigantesca, originale, inquietante, di rottura, dagli indubbi apporti mediterranei soprattutto italiani; un’opera, se vogliamo, “dantesca”. Essa è stata attribuita ad un uomo di Stratford, William Shakespeare, dalle notizie biografiche molto incerte e che i pochi indizi storici sicuri rivelano davvero “piccolo piccolo”.
Il “William Shakespeare”, gestore di una compagnia teatrale e uomo d’affari poco scrupoloso, dedito persino all’usura, nato in una famiglia di semianalfabeti e a sua volta genitore di figli incolti, vissuto in un ambiente ineducato e grezzo, e autore, questa volta accertato, di un testamento sgrammaticato, sarebbe, secondo gli scettici, un puro prestanome dietro il quale si celerebbe qualcuno dalla mente superiore e dalle esperienze culturali e di vita ben altrimenti più ricche.
Tassinari: “La critica Shakespeariana si è arrabattata miseramente nel tentativo di conciliare l’opera di Shakespeare con la vita dell’uomo di Stratford”. Ed è riuscita, finora, a non far smascherare la “frode cosmica”. Ma oggi Tassinari orienta gli scettici verso terreni molto fertili che occorrerà dissodare nella loro interezza. Il nome di John (Giovanni) Florio, come vero autore di Hamlet e degli altri drammi immortali, fu fatto per la prima volta dall’italiano Santi Paladino alla fine degli anni ’20. E solo pochi anni prima l’americana Clara Longworth de Chambrun, nella sua tesi di laurea alla Sorbona, aveva sostenuto che Shakespeare si era ispirato alle opere di John Florio per i suoi lavori teatrali d’ambientazione italiana.
Sulla paternità di John Florio delle opere cosiddette shakespeariane, Tassinari apporta un vortice di argomenti, recando scompiglio sia nei ranghi dei “guardiani dell’ortodossia stratfordiana”, sia in quelli degli “Anti-Stratfordians”. Per quest’ultimi, infatti, la candidatura di un italiano al vertice delle lettere inglesi è considerata, senza alcun dubbio, un puro anatema. E dovremmo forse usare il termine “italiano” al plurale, dal momento che tra i Florio padre e figlio esisteva una “strettissima collaborazione e simbiotica unione”, tanto da poter usare per loro l’espressione “laboratorio di scrittura”.
Ma al fine di indagare sistematicamente tale eventualità, dovrei presupporre che questa play presenta una particolare interpretazione del problema dello scetticismo in quanto tale (scetticismo diretto verso la nostra cognizione dell’esistenza altrui) nella fattispecie un’interpretazione la quale consideri lo scetticismo una forma di narcisismo. Tale interpretazione non costituisce per me una novità dal momento che un libro da me pubblicato anni fa – The Claim of Reason – prende le mosse dalle Indagini filosofiche di Wittgenstein, la cui “mossa” contro il concetto di “linguaggio privato” (concetto che scaturisce dalla sua lotta contro lo scetticismo) viene da me interpretata come “mossa” contro un certo tipo di narcisismo, una sorta di negazione di un’esistenza condivisa con altri.
Il mio libro si conclude con una lettura dell’Otello inteso come rappresentazione degli estremi (dei micidiali estremi) cui il narcisismo deve giungere al fine di preservare intatta l’immaginedi se stesso come scetticismo, al fine di preservare intatta la propria ignoranza, la propria paura della conoscenza, la propria volontà di eludere la conoscenza, e, tutto ciò, sotto la parvenza di una aspirazione alla – e pretesa di – certezza. (1)
Ciò che più mi sorprende nel Coriolano è che in esso il narcisismo viene inteso come un’altra faccia dell’incesto (dell’incestuosità) e che l’incesto viene inteso come una situazione in cui il linguaggio si guasta, crolla sotto la sensazione [la paura] di divenire incomprensibile, sotto la sensazione [il timore] che tu (l’incestuoso) abbia perso il potere (la capacità) di esprimerti: cosa che io, in The Claim of Reason, chiamo “il terrore dell’inespressività”; il destino di Narciso si rispecchia perfettamente nella figura di Coriolano: una figura ogni cui atto viene compiuto in modo tale, per cui la distinzione fra azione e passione sembra non aver più senso; abbiamo quindi una situazione in cui l’esistenza umana diviene precaria, sebbene, forse, trascendibile.
Se alludo a tali nessi con la questione filosofica dello scetticismo non è già perché intendo insistervi nel presente saggio bensì solo per ribadire il mio convincimento che una qualsiasi play di Shakespeare non può fornirmi l’aiuto che da essa vorrei – ai fini delle questioni filosofiche ch’io tratto– ammenoché alla play stessa non si conceda quell’autonomia che è in nostro potere di concederle, non la si veda, cioè, nei propri termini, alle proprie condizioni (in its own terms). Che cosa significa questo? Che cosa è una play di Shakespeare? Cercherò di rispondere a tali interrogativi.
C’è qualcos’altro, inoltre, che mi attrae. Il modo che ho, io, di intendere i conflitti che la play genera mi rinvia continuamente a certe “strade di pensiero” (paths of thought) che molti critici, secondo me, ormai trovano prive di interesse, di convinzione. Tre sono, in particolare, queste strade:
1) quella seguita da coloro che cercano, nella play scespiriana, qualcosa come un’idea del teatro, come dire il concetto che la play ha di sé stessa;
2) quella di chi avverte fremiti e mormorii cristiani sotto la superficie delle parole;
3) quella di chi si aspetta qualcosa che alluda alle origini della tragedia come rituale religioso. Mi attraggono certe “strade della critica” che altri ritengono cieche, allo stesso modo (diciamo) in cui certi poeti sono attratti da parole che, ad altri, suonano banali, trite.
Ma dire, appieno, perché uno è attratto da un’opera – e perché ama interpretarla – può ben essere la meta cui l’interpretazione stessa tende. E il movente di un’interpretazione – al pari di ciò che potremmo chiamare l’intento dell’opera stessa – esiste pienamente solo nella sua soddisfazione.

Penso che (come punto di partenza) su due dati di fatto relativi al Coriolano si sia in genere tutti d’accordo.
Primo: rispetto ad altre tragedie di Shakespeare, in questa manca quella che A.C. Bradley chiama “atmosfera”.
Il linguaggio di essa, al pari del suo protagonista, si mantiene “altezzoso”, tanto austero e tanto riservato quanto rabbia e disprezzo gli consentono di essere. Secondo: la play tratta dell’organizzazione del “corpo politico” (body politic, res publica) e del modo in Interpretazioni politiche del Coriolano di Shakespeare cui tale “corpo” viene nutrito, cioè sostenuto. Penso, inoltre, che i lettori di ogni tipo e tendenza siano disposti a convenire che la play si presta equamente (o comunque naturaliter) sia a una lettura psicologica sia a una lettura politica: da entrambi i punti di vista si è interessati a “chi” produce il cibo e “in che modo” il cibo viene distribuito e pagato. Sul piano psicologico (oggi in pratica si preferisce dire psicanalitico) la play indirizza il nostro interesse sullo sviluppo del carattere di Coriolano. Sul piano politico, la play ci induce a domandarci se siano i patrizi oppure i plebei ad avere la ragione dalla loro parte e – una volta dato per scontato che Coriolano non è adatto al potere politico – se sia la sua “fanciullaggine” o la sua stessa nobiltà a renderlo inidoneo.
Nelle discussioni critiche che ho finora lette, il punto di vista psicanalitico ha prodotto letture più interessanti che non il politico. Una lettura politica può riuscire ovvia, una volta appurato per chi il lettore parteggia, se cioè simpatizza con i patrizi oppure coi plebei; e il partito che il lettore prende è determinato dal modo in cui questi intende il celebre apologo di Menenio Agrippa, la cosiddetta Favola del Ventre, e su chi egli riversa la colpa per la messa al bando di Coriolano. Se pochi sono quelli che trovano realistico supporre che Coriolano sarebbe risultato un buon capo politico, ancor meno sono coloro che negano che, perdendo lui, l’urbe ha perduto il suo maggior eroe e che tale perdita è l’espressione di un grave periodo di crisi dello Stato. Ci troviamo, all’inizio, in un periodo di carestia, un periodo in cui i fermenti di rivolta sono resi “discutibili” dalla minaccia incombente della guerra e dell’invasione; poi ad esso tien dietro un periodo in cui, dopo la vittoria, le polemiche relative alla condotta della guerra creano le premesse per una contro-rivolta da parte del difensore e salvatore della patria. In siffatti periodi di crisi tutti hanno validi motivi e nessuno li ha, tutti hanno buone ragioni dalla loro parte e nessuno ha ragione. Sì che, alla fine dell’atto IV, Aufidio sintetizza la situazione nel modo seguente:
Così le virtù nostre
dipendono da come sia il momento interpretato…
Un incendio divora un altro incendio e chiodo scaccia chiodo.
L’un diritto l’altro diritto opprime,
l’una forza l’altra forza vanifica.
Si direbbe che proprio in questa discordia (division) di incendio e diritto consista la tragedia, ma basta questa descrizione a render conto dei particolari risvolti insiti in quegli eventi, in quanto distinti dalle sciagure e dalle ironie insite in qualsiasi situazione rivoluzionaria? Anche la più cogente interpretazione politica – qual è quella fornita da Bertold Brecht nella discussione (2) da lui tenuta con i membri della sua compagnia teatrale intorno a questa play – sembra avere ben poco da aggiungere, una volta messo in chiaro che la scelta di campo (a favore dei plebei) è utile e vitale (viable) sia drammaticamente sia testualmente.
Non è faccenda da poco. Sta a dimostrare che il testo di Shakespeare – o ciò cui alludiamo come all’umanità di Shakespeare – lascia amplissimo spazio per distinzioni fra i vari “gruppi” (clusters) di cittadini [plebei] e mostra altresì il peso della loro comune posizione, in opposizione a quella dei patrizi. E ritengo che ciò a sua volta stia a dimostrare che la politica della play è essenzialmente la politica di una data messa-in-scena di essa, tale per cui non dovremmo aspettarci che a dirimere le sue questioni politiche basti un’interpretazione di quello che si potrebbe chiamare “il testo a sé stante”.
Si può dire che la discussione di Brecht acquista forza in quanto riesce ad indurci a non interpretare (soprattutto a non interpretare il cibo) ma bensì ad attenerci al dato di fatto da cui la play prende le mosse: il fatto cioè che i cittadini di Roma sono in rivolta perché c’è una carestia (e poiché questa carestia viene da Interpretazioni politiche del Coriolano di Shakespeare essi “interpretata” in un determinato modo). Le famiglie povere patiscono la fame e la plebe ritiene (correttamente, a quanto ne sappiamo) che i patrizi si siano accaparrati i cereali. Non “interpretare” ciò significa, in termini pratici o teatrali, che noi siamo propensi a riconoscere che questo “gruppo” [i plebei] è composto di esseri umani, di singoli individui, che svolgono un dato mestiere e abitano in determinati quartieri, e che attendono notizie circa l’esito di certe trattative. Il dato di fatto della loro ordinaria umanità è quanto di più “spettacolare” (impressive) può contrapporsi al disprezzo che i patrizi nutrono per loro: un dato di fatto che non dovrebbe risultare evidente solo a un marxista, in quanto esso denuncia quanto “misterioso” ed evasivo sia il linguaggio della classe dirigente, quanto tale linguaggio sia “soggetto” a quella cui possiamo pensare come alla “politica dell’interpretazione”. Tuttavia possiamo anche avere la sensazione che i frequenti rimandi al cibo e alla fame, al cannibalismo e al disgusto, significhino pur qualcosa, ed invitino in qualche modo a una qualche “interpretazione”; e che il valore dell’assistere a una recita di questa particolare play sia una funzione del valore che singoli esseri umani attribuiscono alle “battute” di essa. Gli psicanalisti, naturalmente, privilegiano quelle “immagini” del cibo e del cibarsi che connettono Coriolano a Volumnia sua madre. In un suo recente saggio dal titolo “Anger’s My Meat”: Feeding, Dependencyand Agression in “Coriolanus” (“La rabbia è la mia vettovaglia”: Nutrizione, dipendenza e aggressività nel Coriolano) (3) la professoressa Janet Adelman fornisce un chiaro ed imparziale resoconto di un ventennio di interpretazioni psicanalitiche del cibo e del cibarsi –relative a questa play – e qui intendo avvalermi di alcuni dei brani del Coriolano da lei citati, sia pure per poi porre l’accento su aspetti diversi.
Due volte Volumnia evoca l’allattamento. Nella scena terza del primo atto, essa dice alla nuora Virginia, per rimproverarle di stare in apprensione per la sorte del marito:
… le mammelle di Ecuba
quando allattava il figlioletto Ettore
non più belle apparivan che la fronte
d’Ettore stesso allorché sprizzava
sangue, fenduta da una spada greca,
ch’egli sprezzava.
Quando intercede per la prima volta presso di lui, nella seconda scena del terzo atto, Volumnia dice al figlio:
… Fa’come vuoi.
A me la virtù devi: la suggesti
al mio seno — laddove del tuo orgoglio
solo a te stesso tu sei debitore.
Entrambe le invocazioni ci inducono a pensare cosa sia che il figlio succhiò al seno della madre, cosa sia ciò di cui fu nutrito, specie dacché ci si rende conto che entrambi dichiarano di patir la fame. È solo dopo la partenza di Coriolano per l’esilio, quando Menenio lechiede se vuol cenare con lui, nella seconda scena del quarto atto, che Volumnia sbotta:
La rabbia è la mia sola vettovaglia.
Di me stessa mi cibo — e io di fame,
a furia di nutrirmi, morirò.
Nella terza scena del secondo atto, allorché si fa beffe dell’usanza che vuole che il candidato alla carica di console chieda “ritualmente” al popolo i suffragi, Coriolano dice:
Patir la fame e morir di fame
preferisco — piuttosto che piatire ciò che mi spetta.
Madre e figlio, dico io, stanno entrambi tribolando la Interpretazioni politiche del Coriolano di Shakespeare fame, sempre – intendo – dal principio alla fine, e non soltanto quando hanno occasione di dirlo. Secondo me, quando dice di cibarsi di sé stessa, Volumnia non allude a una rabbia estemporanea, bensì a quella rabbia che costituisce la predominante e divorante passione di tutta la sua vita: ed è quindi la rabbia ch’ella trasmise al figlio col suo latte, quantunque – nel brano citato – le dia il nome di “virtù” (virtus, valore, eroismo, valiantness nel testo inglese).
In tal caso, se Volumnia e quindi Coriolano stanno a esemplificare l’identità virtù-valore, allora, va altresì inteso che “valore” sia lo stesso che (si identifichi con) “accesso alla propria rabbia”. Volumnia si proclama “nell’ira, simile a Giunone”, cioè simile a una dea (atto IV, scena 2a) e il tribuno Sicinio, per evitare di esser messo a confronto con lei, a tale divina ira allude quando esclama: “Costei è pazza, dicono” ( a.IV, sc.2); orbene, io ritengo che nella su citata battuta di Coriolano, che nel testo originale suona “better it is to die, better to starve / than crave…” l’enfasi vada così spostata: “better it is to die, better to starve…” perché non tanto Coriolano “sottolinea” che è meglio meritare che “piatire” (craving = bramare, chiedere con insistenza), quanto asserisce quella ch’è una sua scelta per l’avvenire, ossia riafferma o confessa la forma di vita (interiore) cui è votato. Trovo che porre l’accento enfatico sui verbi (to die, to starve) sia più consueto, ma lo trovo anche pregiudizievole (prejudicial). Coriolano e Volumnia sono – per me – due morti di fame (starvers, hungerers). Essi manifestano tale condizione come un nome o una definizione dell’umano, al pari di “esser mortali”. E manifestano ciò, altresì, come una condizione di insaziabilità (patir la fame nutrendosi, nutrimento che equivale a privazione). Si tratta di una condizione che, talvolta, viene descritta come “infinitudine del desiderio” in contrapposto alla finitudine del corpo. Mail “patire la fame” di Volumnia e di suo figlio lascia intendere che tale infinitudine (infiniteness) non è la causa dell’umana insaziabilità: ne è piuttosto l’effetto. È l’effetto non già di una sterminata quantità, come se il “sé” avesse sterminate riserve di desiderio; bensì di una sterminata struttura, come se il desiderio avesse una sterminatezza strutturale (a structure ofendlessness). Un’illustrazione di siffatta struttura è fornita da Narsiso, per il quale ciò che si agogna è qualcuno che agogna, e la bellezza si raffigura come nostalgia. Il morir-di-fame-mangiando si presenta a Coriolano come l’esser consumato dalla fame, e le parole con cui egli allude alla fame sono “desiderio” e “brama”. E ciò di cui egli ha sempre più fame è il nonaver- fame, il non-desiderare: vale a dire il non-essere mortale. Si rilegga, nella scena terza del secondo atto, il seguente brano del suo colloquio con esponenti del popolo romano:
CORIOLANO Voi sapete per quale motivo mi presento qui.
PRIMO CITTADINO Lo sappiamo. Dicci tu cosa t’indusse a presentarti.
CORIOLANO Il mio merito, le mie benemerenze.
SECONDO CITTADINO I tuoi meriti, dici.
CORIOLANO Appunto. Non già il mio desiderio.
TERZO CITTADINO Come sarebbe, non il desiderio?
Se desideri esser privo di desideri (desireless) e c’è qualcosa di cui hai nondimeno desiderio, ebbene, come l’esprimi? Con quali parole? Come formuli, cioè, la tua richiesta? La risposta di Coriolano a tale paradosso è: occorre divenir perfettamente meritevole. Poiché aver fame è aver bisogno, è sentire la mancanza di qualcosa, egli ha fame di non mancar di nulla, di essere completo: come una spada. Se rifletto su ciò è nel tentativo di rendere giustizia al “senso” che si ha di Coriolano come di uno che, qui, non reagisce alla propria situazione nei riguardi dei plebei(verso i quali prova solo disdegno, e da tale incontrollabile disdegno è “intrappolato”) ma reagisce bensì, in primo luogo, alla propria situazione nei confronti di sé stesso, come si addice a un Narciso, preso “in trappola” primamente Interpretazioni politiche del Coriolano di Shakespeare da una incontrollabile logica. Pur trovandomi io d’accordo con Plutarco, laddove questi, nella sua Vita di Caio Marzio Coriolano, considera quest’ultimo “del tutto disadatto a conversare con chiunque”, devo però precisare che interpreto questa asserzione nel modo seguente: non già ch’egli parli in preda a rabbia o disprezzo (rabbia e disprezzo non sono ingiustificabili) ma bensì che, sebbene in certe circostanze egli sia in grado di esprimere soddisfazione, non riesce mai però ad esprimere un desiderio e, allora, non può parlare affatto. Il punto non è tanto ch’egli non voglia chiedere ciò che pur vuole avere quanto, piuttosto, che non può volere/aver bisogno [in inglese, want ha entrambe queste valenze] di qualsiasi cosa che egli debba chiedere. Non gli resta pertanto che divenire – come notano più o meno sia patrizi sia plebei – un dio. Quale dio? Vedremo di arrivarci.
Seguitiamo, per adesso, a sviluppare il paradosso dell’aver fame (hungering). Essere “consumato” dalla fame, nutrirsi di sé stesso, deve insieme configurarsi come “servire da cibo”, essere divorato. [In inglese to feed significa sia “mangiare” sia “dar da mangiare”, come to suckle vale tanto “poppare” quanto “allattare”. Una analoga ambivalenza si riscontra in italiano nel verbo “cibare” che significa anche “cibarsi, mangiare” sebbene questa sia un’accezione arcaica: Questi non ciberà terra né peltro… etc. NdT] Pertanto, l’aver fame, il morir di fame, procurano anche a Coriolano e Volumnia la sensazione di essere “cannibalizzati” (4). Il concetto di cannibalizzazione affiora qua e là in tutto il Coriolano. Esso è sintetizzato nel sottotitolo che ho dato al presente saggio: “Chi è che il lupo ama?” Questa è la domanda (Who does the wolf love?) che, all’inizio dell’atto secondo, Menenio Agrippa rivolge ai due tribuni della plebe. Uno di essi risponde, ed è innegabile verità: “L’agnello.” Al che Menenio, interprete di favole, ribatte: “Appunto: per divorarlo. Come gli affamati plebei vorrebbero divorare il nobile Caio Marzio.”L’obiezione dell’altro tribuno – “Egli è un agnello, inve- ro, che bela come un orso” – non respinge, in modo esplicito, questa interpretazione di Menenio. Ciò che essa (interpretazione) ha di provocatorio è, ovviamente, che, all’inizio, erano i plebei, non già i patrizi, e men he meno Coriolano, ad esser presentati come “agnelli”, ossia come vettovaglia per i lupi patrizi. Quando Menenio, nella scena prima del primo atto, tenta di dissuadere i plebei dall’insurrezione, egli dichiara che “i nocchieri dello Stato hanno cura di voi sì come padri”, al che uno dei cittadini ribatte: “Cura di noi!… Quando non son le guerre a divorarci, ci divorano loro: ecco, tutto l’amore che ci portano!” Tale fantasia trova conferma nelle parole del generale Cominio, allorché questi dice che Coriolano va alla battaglia come ad un festino (a.I, sc.10). E il concetto del guerriero Coriolano che si pasce di una genia inferiore, è ribadito allorché questi, nel corso d’una battaglia, così minaccia chi indietreggiasse: “lo scambio per un volsco / e il filo assaggerà della mia spada” e, così, sembra alludere alla spada come ad un coltellaccio da cucina. L’idea di una ingovernabile voracità echeggia anche nelle parole di Volumnia quando rammenta come il figlio, da piccolo, lacerasse tra i denti una farfalla. D’altro canto, Coriolano nel quarto atto, ad Anzio, dice ad Aufidio che il nome soltanto è quello che avanza di lui, poiché tutto il resto è stato divorato “dalla crudeltà e l’invidia del popolo”. E Menenio, il cui senso della giustizia è messo a dura prova, fra l’altro, dal timore dei disordini civili e delle sciagure che ne deriverebbero, batte a sua volta (a.II, sc.1) sul tasto del cannibalismo:
Non vogliano gli dèi
che Roma nostra, la cui gratitudine
verso i degni suoi figli resta inscritta
nel gran libro di Giove, come madre
snaturata divori i nati suoi.
In tale descrizione di Roma come potenziale madre cannibalesca, l’accorto lettore può ben ravvisare un’allusione a Volumnia, la cui identificazione con l’Urbe è rafforzata in vari altri modi, nonché dalla stessa Volumnia quando, nella scena terza del quinto atto, intercedendoper la seconda volta presso il figlio, così gli dice:
… ché muovere all’assalto
della tua patria, oh, sarebbe come
se calpestassi (e mai non lo faresti)
il grembo di colei che ti diè vita!
Non è affatto fuori luogo pensare che nella visione evocata da Menenio di Roma quale “madre snaturata” egli proponga un’identificazione fra una madre che divora il figlio e una madre che divora sé stessa: infatti, qualora Roma divorasse tutti i romani, addio Roma— poiché, come dice uno dei tribuni: “Che cos’è la città, se non la gente?” (a.III, sc.1).
Il paradosso e la reciprocità dell’aver fame/affamare (hungering in inglese ha entrambe le valenze) si può rilevare nella domanda “Who does the wolf love?” (Chi è che il lupo ama?). Se si intende chiedere chi è l’oggetto dell’amore del lupo, più grammaticalmente corretto sarebbe, in inglese: “Whom does the wolf love?” (5). Ma tale forma corretta (propria semmai del parlare forbito dei patrizi) escluderebbe una più ambigua interpretazione, vale a dire: di chi è, il lupo, oggetto d’amore? [In italiano la sottigliezza è meno avvertita, ammenoché non si voglia distinguere fra “chi è che il lupo ama?” e “chi è che ama il lupo?” ma, praticamente, le due frasi si equivalgono. Semmai, noi diremmo, nel secondo caso, per escludere ogni ambiguità: “il lupo, chi è che lo ama?” NdT] Orbene, la risposta “l’agnello” non esclude né l’una né l’altra interpretazione [come invece l’escluderebbe, in latino, la diversa desinenza del soggetto e del complemento oggetto, lupus-lupum, agnus-agnum, NdT] e, quindi, tutto dipende dalla scelta di campo dell’interprete. Entrambe le interpretazioni – la costruzione attiva e la passiva – sono operanti nell’intera play. Ne ho fatto già esplicita menzione nel caso di feeding (nutrire/nutrirsi) e suckling (allattare/poppare). Ma la trovo pertinente, sebbene meno perspicua, anche nel seguente scambio di battute:
CORIOLANUS Let them hang.
VOLUMNIA Ay, and burn too.
(La traduzione di Guido Ferrando, nell’ediz. Sansoni a cura di Mario Praz, dice: “Che siano impiccati.” “Sì, e che siano anche arsi vivi”. Alla lettera le due frasi potrebbero anche intendersi così: “Lascia che pendano impiccati.” “Sì, e che brucino anche.”) (a.III, sc.2).
Una delle funzioni insite in siffatta amplificazione consente, secondo me, di suggerire che Volumnia ha il senso dell’inevitabile riflessività d’azione (reflexiveness of action) nella loro Roma: i verbi impiccare (hanging) e ardere(burning) denotano azioni compiute su qualcuno, oppure vanno intesi come verbi riflessivi? La circolarità del cannibalismo – del mangiatore mangiato da ciò che mangia – seguita dunque ad affiorare, dal principio alla fine. Possiamo scorgervi una identificazione del narcisismo come cannibalismo. Fin dall’inizio. Nella prima scena del primo atto così Coriolano conclude una sua lunga tirata ai cittadini:
Per qual motivo andate voi sbraitando
contro il Senato che (gli dèi volendo)
vi tiene a freno, altrimenti voi
gli uni con gli altri vi divorereste?
E, verso la fine, “vediamo” Roma che divora sé stessa nelle immagini, ossessivamente proposte, di Coriolano che dà fuoco a Roma. È stato A.C. Bradley, in una sua conferenza tenuta alla British Academy, a porre per primo in risalto l’insistenza con cui ricorre nel Coriolano l’immagine del fuoco, di Roma in fiamme. Aggiungerei, da parte mia, che (al lume del tema del patire la fame,del cannibalismo) il fuoco in questa play viene precipuamente inteso come ciò che divora le cose che brucia. Si può dire che l’ardere come forma di vendetta è la proiezione su Roma, da parte di Coriolano, di ciò che questi ritiene che Roma faccia a lui. Ciò è senz’altro vero ma non basta, se non ci si vuol limitare a vedere nel “vindice” Coriolano un uomo essenzialmente simile ad Aufidio, vale a dire uno che tira a far pari e patta: il quadro va pertanto rifinito. Supponiamo che, come io credo, nella sua famosa frase d’addio: “I banish you! Io vi bandisco!” (a.III, sc.3) in Coriolano si sia già iniziato il processo di “consumare” Roma, di incorporarla, divenire essa. Allora, il generale Cominio quando, dopo averlo invano scongiurato di salvare la patria, dice di lui: “egli siede sull’oro ed è il suo occhio / rosso come volesse ardere Roma” (a.V, sc.1) ha mal compreso ciò che ha visto. Ha creduto cioè che Coriolano contemplasse una scena a venire, laddove l’occhio di Coriolano era rosso delle fiamme che già ardevano in lui, divorandolo. Quel divorare la Roma effettiva mediante un effettivo fuoco sarebbe, quindi, alla lettera, espressione dell’auto-divorarsi (self-consuming). In tal modo la città capirebbe cosa essa ha fatto a sé stessa. Coriolano le darà – orribilmente – ciò che merita. In tal modo il dramma della vendetta viene ulteriormente interpretato. Queste varie allusioni al cannibalismo illustrano, tutte, l’antico sentimento per cui l’uomo è lupo all’uomo. Si attribuisce a Plauto (cui Shakespeare è notoriamenteindebitato) il merito di avere per primo dato espressione letteraria, homo homini lupus, a tale sentimento. Esso riaffiora, in tempi moderni, fra l’altro, nell’Opera da tre soldi di Brecht. Ma la domanda “who does the wolf love” ha altre due più remote scaturigini che dobbiamo esplorare. In Primo luogo, vi è un’eco del concetto che il divorare può essere espressione d’amore. In secondo luogo: se, come io credo, v’è motivo qui di scorgere nel “lupo” la mitica “lupa” che è il simbolo stesso di Roma, avendone allattato i fondatori, v’è motivo altresì di vedere nell’agnello ch’essa ama (o che l’ama) il mitico animale identificato con il Cristo.
A questo punto, vorrei esplicitare una discordanza, circa le motivazioni di Coriolano, fra l’interpretazione che ne do io e quella, psicanalitica, che ne dà Janet Adelman (6). Nel tentativo di Coriolano mirante a rendersi “disumanamente indipendente” la Adelman legge il suo orrore della dipendenza, e ritiene che la sua rabbia sia la la “conversione” di un desiderio di dipendenza in rabbia (appunto) contro chi dipendente lo rende. A suffragio della sua tesi, la Adelman dà una lettura tutta propria di un brano che ho già citato:
…le mammelle di Ecuba
quando allattava il figlioletto Ettore
non più belle apparivan che la fronte
d’Ettore stesso allorché sprizzava
sangue, fenduta da una spada greca,
ch’egli sprezzava.
Ecco la lettura che ne dà la Adelman:
Il sangue è più bello del latte, la ferita lo è più della mammella, la guerra lo è più del pacifico allattamento (peaceful feeding)… Ettore viene immediatamente trasformato da bocca infantile poppante in sanguinante ferita. Tacita mediatrice fra mammella e ferita è la bocca dell’infante: in tale imagistica metamorfosi, poppare equivale a essere ferito, la bocca diviene la ferita, la mammella diviene la spada… Ma, al tempo stesso, dappoiché l’immagine di Volumnia suggerisce la vulnerabilità inerente al poppare/allattare (feeding) essa suggerisce altresì una maniera atta a scongiurare tale vulnerabilità. Nella sua immagine, il nutrire/nutrirsi, l’incorporare, si trasforma in in uno “sputar fuori”, in un aggressivo espellere: la ferita di nuovo diviene la bocca che sputa… Pertanto la ferita che sputa sangue diviene non un segno di vulnerabilità, bensì uno strumento d’attacco. (pag. 131)
Ciò è molto fine e non dev’essere negato. Ma la trasformazione della bocca di Ettore in una ferita non deve a sua volta negare due ulteriori valenze di questi difficili versi. Prima: quando Ettore disprezza (contemns) le spade greche, egli va anche pensato combattente, va pensato come uno che brandisce la spada,quindi la bocca si trasforma in un’arma da taglio, o come tale è vista: la madre che allatta viene pertanto rappresentata come una che viene ferita di spada dal figlio-eroe, divorata da colui che sta nutrendo. Seconda: i su-citati versi stabiliscono un’equazione fra latte materno e sangue d’uomo, per cui dobbiamo intendere lo sputar sangue dell’uomo (man’s spitting blood) inbattaglia non soltanto come un attaccare ma altresì – in qualche modo – come un “procacciare cibo” in maniera maschile. Ma in che modo? Si tenga presente che il modo adottato da Coriolano per evitare di chiedere qualcosa – cioè per evitare di esprimere un desiderio – consiste in ciò che egli chiama “meritare la cosa”. Il suo merito consiste nella virtus (coraggio, valore, valiantness) ragion per cui il suo sputar sangue in battaglia è ilmodo ch’egli ha di meritare di venir nutrito, vale a dire, meritare di esser divorato, di essere amato incondizionatamente. (Guerra e nutrimento vengono spesso abbinate in questa play. Un plebeo dice: “Se non ci divoran le guerre, ci divorano loro” [a.I, sc.1]. E Cominio dice a Coriolano: “Vieni a questo festino dopo aver già cenato a sazietà” [a.I, sc.9] ma, poi, Cominio, non coglie appieno il nesso.) Esser nutrito da Volumnia equivale a esser dato in nutrimento a lei [to be fed by=to be fed to]. Ma dacché il giusto, o efficace, sanguinare dipende (data l’equazione sangue=latte) dal suo essere una forma del nutrirsi, del nutrire, ecco che “procacciare sangue” (providing blood) identifica Coriolano con sua madre. La fantasia di Volumnia qui lascia intendere che l’adeguata reciprocazione, per aver ella nutrito il figlio, è che questi divenga lei, quasi a titolo di rimozione del fatto, arbitrario, ch’essa è nata donna; e dappoiché è un modo di immetterla nel mondo, è anche un modo di darle la vita. Un’analoga fantasia di reciprocazione, da parte di Coriolano, sarebbe: rendere a Roma il dono da essa ricevuto, allattare Roma con la virtus che egli da lei ha poppato.
Questa fantasia produce contraddizioni che si scontrano con la furia di contraddizioni che noi avvertiamo in Coriolano (per esempio nei suoi contraddittorii desiderii di dipendenza e indipendenza). Poiché, infatti,egli può restituire il nutrimento ricevuto soltanto qualora Roma (intesa come popolo romano) se lo meriti. Quindi la mancanza di meriti nel popolo comporta il suo demerito, comporta ch’egli non può fare la cosa per cui si acquista amore; la logica gli impedisce ogni forma di reciprocità. Il fatto ch’egli nutre un assoluto disprezzo per il popolo e che, al tempostesso, ha assoluto bisogno del popolo è una cosa che lo manda fuori dai gangheri. (Ciò implica, a sua volta, che io non posso intendere i sentimenti di Coriolano nei riguardi dei plebei come diretti, semplicemente, contro la loro codardia; ritengo ch’egli abbia bisogno dei loro meriti, della loro meritevolezza, per così dire, per motivi tanto privati quanto pubblici.) L’altra parte di ciò che lo manda fuori dai gangheri è che né il popolo né sua madre –nessuna delle due cose che significano Roma – capiranno mai la sua situazione. Né madre né popolo intendono che l’intendimento ch’egli ha della propria virtus (del proprio eroismo, del proprio valore, della propria meritorietà) è intendimento di sé stesso come procacciatore (provider) e che questa è la condizione del suo ricevere il proprio sostentamento. (Qui s’ha da presumere ch’egli condivida la fantasia di sua madre dell’equazione latte=sangue [in italiano il latte e il sangue sono abbinati in un’espressione popolare che vale: crepare di salute, NdT] come se nulla in lei vi fosse che lui non avesse introiettato.) Il popolo, al contrario, lo accusa (e anche questo lo manda su tutte le furie) di rifiutargli il cibo; mentre sua madre considera il suo eroismo puramente come “durezza”, privo cioè di ogni tenerezza; o come pura paternità, privo di maternità; e lo considera meritevole di qualcosa di più che non il riconoscimento di ciò ch’egli procaccia (di ciò cui egli provvede), qualcosa di più della sua (di Coriolano) auto-stima (self-account, alla lettera: resoconto di sé), come se l’esser fatto console fosse invero qualcosa di più. (“Sappi, madre, che io preferirei / essere servo loro a modo mio / anziché comandarli a modo loro” a. I, sc.1) A causa di tali fraintendimenti essi [madre e popolo] lo hanno entrambi già abbandonato, già “divezzato”, prima ancora che lui venga formalmente esiliato. Questo antecedente rifiuto consente, pertanto, di intendere la rabbia di Coriolano allo stesso modo in cui Volumnia interpreta la propria rabbia, vale a dire come “lamento” (“…e lamentatevi com’io mi lamento / nell’ira simile a Giunone”). Senza contraddirla, possiamo ulteriormente interpretare questa interpretazione della rabbia di Volumnia. Possiamo spingerci a interpretarla come “depressione”.

Per caratterizzare il mio intento, posso precisare che queste che io chiamo “fantasie” costituiscono un tentativo di arrivare all’origine delle parole: non esattamente all’origine del loro significato, bensì all’origine della loro “produzione”, del “valore” che esse hanno quando ricorrono (occur=anche accadere, venire in mente). Ho caratterizzato qualcosa di simile a questa ambizione del criticismo in varii modi, nel corso degli anni, e l’ho posta in relazione a ciò che io intendo come “caratteristica procedura della comune filosofia del linguaggio”. (Vedasi, per esempio il mio saggio “The Avoidance of Love: A Reading of King Lear”, “La fuga dall’amore: una lettura di Re Lear”). E giovano tali precisazioni? Aiutano, mettiamo, a comprendere la susseguente condotta di Coriolano: com’egli giustifichi il suo intento di dar fuoco a Roma e com’egli ne venga dissuaso da Volumnia. Non è arduo convincere sé stessi di aver capito queste cose. A me esse sembrano misteri. Accennerò alle risposte da me date ai varii interrogativi e spiegherò in che modo tali risposte servono a interpretare il nostro rapporto con questa play, il che per me significa capire cos’è una play scespiriana (in questo caso il Coriolano).
Preliminarmente, voglio mettere in tavola una questione che potrebbe, altrimenti, molestare la nostra comprensione della play. In essa, il “rapporto con la madre” è sì onni-presente che non possiamo non chiederci: e il padre? Che fine ha fatto il padre di Coriolano? O, comunque, ci si chiede se sia il caso di chiederselo. Orbene, a me sembra che la play susciti tale interrogativo in tre diversi modi. Li cito in ordine decrescente di ovvietà. Primo: a Menenio viene attribuito un ruolo paterno sui generis, ossia il ruolo di un certo tipo di padre, ma la difficoltà stessa di vedere in lui il vero padre di Coriolano – vale a dire il marito o l’amante di Volumnia – ci sprona a immaginare l’aspetto che costui potrebbe avere. Secondo: l’attaccamento erotico di Coriolano alla battaglia e ai combattenti fa pensare tanto a una ricerca del padre quanto a una fuga dalla madre. Ciò offrirebbe una spiegazione all’altrimenti inesplicabile (a mio avviso) uso che la play fa dell’episodio in cui – nella Vita di Plutarco – Coriolano, esausto dopo la pugna vittoriosa, chiede che a un certo uomo della conquistata Corioli sia risparmiata la schiavitù, dicendo che talvolta ha avuto ricetto nella casa di quel poveraccio — il cui nome s’accorge di aver dimenticato. Orbene, la vaga identità di quell’uomo e l’amnesia di Coriolano in Shakespeare – a differenza che in Plutarco – a me fanno pensare che l’innominato la cui sorte Coriolano desidera mitigare sia, vagamente, una fugace immagine del padre suo (7).
Terzo, e così poco ovvio da potersi attribuire a una mia allucinazione: il tentativo di “immedesimazione mitologica”, da parte di Coriolano, allorché contempla Roma estatico, è secondo me il tentativo di identificarsi con il Padre. (Non accennerò, qui, all’eventualità, o alla fantasia, che una matrona patrizia sia, simultaneamente, padre e madre; né all’idea che, sostituendosi al padre Coriolano divenga il padre di sé stesso.) Mi chiedo ora in che modo dobbiamo intendere il ritorno di Coriolano e il suo voltafaccia. La risposta dipende da come ci si raffigura il rapporto fra Coriolano e l’altro agnello sacrificale, cui ho già accennato: l’agnello di Dio, l’agnus Dei, Gesù Cristo. Raffigurarsi un rapporto fra loro non significa assimilarli: per me, Coriolano non tanto imita Cristo, quanto compete con lui. Ci sono, oviamente, punti oscuri e – sebbene tutto dipenda da un’accurata definizione del suddetto rapporto – posso soltanto, qui, indicare alcuni elementi che dovranno far parte della raffigurazione stessa.
Ho già detto che la soluzione di Coriolano del paradosso di “aver fame di non aver fame”, “aver bisogno di non aver bisogno”, “chiedere di non chiedere” è: basta diventare “un” dio. Ora possiamo vedere che è Cristo “il” dio giusto grazie al modo in cui egli intende la sua missione e procaccia cibo non-materiale, cibo per lo spirito, per l’immortalità; e perché è grazie a lui che il sangue può essere inteso come cibo. Se si accetta questa congettura, se ne può ricevare una sorprendente conferma da alcune azioni di Coriolano e da alcune descrizioni dei suoi atti. (Non mi interessa asserire che Coriolano è in certo qual senso un capro espiatorio, al modo in cui forse lo è qualsiasi eroe tragico; bensì asserire ch’egli è una specifica accezione di questo capro espiatorio.) Consideriamo in particolare due sue azioni. La prima, è il rifiuto di mostrare alla plebe le sue ferite. Mi vien fatto di collegare tale rifiuto all’episodio evangelico di Cristo che mostra ai discepoli le sue piaghe, al fine di dimostrare la sua resurrezione, e, in particolare, alle parole che Gesù rivolge all’apostolo Tommaso, che non era presente alla scena e che, in seguito, chiese di “vedere per credere”, e Gesù allora gli disse: “Quia vidisti me, Thoma, credidisti; beati qui non viderunt, et crediderunt.”(Giovanni, 20:29)
Poiché Tommaso non voleva credere, Cristo lo invitò a toccare con mano: “Infer digitum tuum huc…”; Aufidio, nella scena 10a del primo atto del Coriolano, dice: “la mia feroce mano laverò / nel sangue suo.” Non voglio spingere più oltre l’analogia: mi rendo conto che alcuni buoni lettori la riterranno puramente accidentale; ma penso altresì che i buoni lettori potrebberoessere spaventati dalla sovreccitazione che una tale analogia può provocare. La seconda azione ha luogo, nella scena 3a del quinto atto, allorquando Volumnia, tenendo per mano i figlioletto di Coriolano e accompagnata da sua moglie Virgilia e dalla di lei amica Valeria, si presenta a Coriolano, davanti alle porte di Roma, per la sua “seconda intercessione”. Ritengo che qui sia evocata la comparsa, ai piedi della croce di Cristo, di tre donne il cui nome comincia con la tessa lettera (la M in questo caso, non la V) accompagnate da un maschio, che Gesù vede come un figlio della Madonna sua madre (Giovanni19:25-27) (Dare un figlio a sua madre presagisce un mistico matrimonio.) Non credo si possa restare convinti da siffatte analogie ammenoché non si abbia, in precedenza, avvertito un nonsoché di… come dire?… di mistico in tali momenti. Perciò più sopra ho parlato di “punti oscuri” (shadowy matters) ma non in senso negativo, tutt’altro. È un modo atto a comprendere il consiglio che (nella sc.2a del terzo atto) Volumnia dà a Coriolano, affinché, quando questi rivolge il suo appello al popolo, manifesti con la mimica (act out) il significato della propria presenza:
… poiché in tali circostanze
eloquente è più l’atto assai del detto:
dell’ignorante gli occhi son più dotti
che non i suoi orecchi…
Per me, questo è un consiglio che Shakespeare dà al suo pubblico, alludendo in certo qual modo alla ragione per cui le parole, in questa particolare play, possano suonare (diversamente dal solito suo) ineloquenti. Un’ulteriore conferma del nesso fra Coriolano e la figura del Cristo si può ravvisare, come ho già detto, in certe “descrizioni” dei suoi atti. Indicherò adesso solo alcuni parallelismi, attingendoli dall’Apocalisse. In questo libro giovanneo la figura centrale è un agnello; ci sono poi, fra le altre figure, un “drago rosso” e un cavallo bianco in groppa al quale c’è un cavaliere “che si chiama il Fedele e il Verace”, i cui “occhi erano come una fiamma di fuoco” e “portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui”; costui brucia una città la quale si identifica in una donna: questa è la città (Babilonia) che la tradizione cristiana assimilerà a Roma. Io per me associo l’incipit della diatriba di Coriolano contro i popolani – laddove egli rimprovera loro il desiderio di attendersi “buone parole” da lui, liete novelle, e li accusa di non amare “né la pace né la guerra” – con il messaggio che il Cristo detta allo scrittore dell’Apocalisse: “Scio opera tua: quia neque frigidus es, neque calidus: utinam frigidus esses, aut calidus; sed quia tepidus es, et nec frigidus, nec calidus, incipiam te evomere ex ore meo.” (In una traduzione italiana recante l’imprimatur della Società Biblica Britannica e Forestiera: “Io conosco le tue opere: tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente! Così, poiché sei tiepido, e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca” Apocalisse, 3:15- 6) (A ciò in Plutarco potrebbe più o meno corrispondere il seguente brano della Vita di Coriolano: “Quindi Marzio – uomo robustoso che, per sua natura, mai non cedeva in qualsivoglia caso, come chi pensi che prevalere sempre, e aver la meglio in ogni controversia, sia un Segno di magnanimità, uomo di non vile né ignobile indole, che sputa fuori rabbia dalla più debole e passionale regione del cuore, così come da un ascesso schizza fuori sanie – se ne tornò a casa….” Quali che siano le ambiguità di tali parole [l’Autore cita Plutarco nella “celebre” traduzione di Sir Thomas North, 1535- 601, quindi coevo di Shakespeare, NdT] è pur sempre lampante la metafora centrale: quando Coriolano è arrabbiato, le sue parole sembrano pus che sprizza da una ferita infetta (8). Il leit-motiv di questa play “sul” cibo, “sulla” fame, è il tema del disgusto, del- la ripugnanza [l’Autore qui usa un vocabolo di suo conio: revoltedness; e revolt, ribellione, vale anche “disgusto”, in accezione arcaica, NdT]. Sia il Coriolano sia l’Apocalisse vertono su personaggi inaspriti, amareggiati, disgustati da coloro cui hanno fatto del bene, le cui vite hanno salvato e sostentato.) Se siano o non siano convincenti, codeste analogie, è cosa che, naturalmente, ciascuno ha da valutare da sé. Ammesso che siano in qualche modo operanti,esse operano al fine di rendere comprensibile in che cosa consiste l’identificazione di Coriolano con Cristo (entrambi sono procacciatori di cibo spirituale messi al bando) e in che modo Coriolano giustifica la sua volontà di distruggere Roma (il popolo romano è privo di fede e quindi va condannato) e, inoltre, perché poi Coriolano cambia idea, circa la distruzione. In genere si ritiene che Volumnia riesce a dissuaderlo facendo leva su sentimenti umani, sugli affetti familiari, insomma mostrandogli com’egli non sia affatto “inumano”. Ciòè vero, ma va notato, innanzi tutto, che Coriolano ha accesso agli affetti familiari [tali affetti si risvegliano in lui, cioè] quand’egli vede appressarsi le tre donne e il bambino; e, in secondo luogo, che tale sentimento non basta – secondo me – a spiegare le (render conto delle) dolenti parole che Coriolano rivolge a sua madre, “tenendola per mano, silenziosa”, nella scena terza del quinto atto:
Oh madre, madre!
Cos’hai tu fatto? Guarda! Si dischiude
il cielo, e di lassù gli dèi, guardando
questa scena che è contro natura,
di noi ridono. Oh madre, oh madre mia!
Tu una lieta vittoria hai riportato,
per Roma, ma, ahimé, quanto a tuo figlio…
credimi! devi crederlo!… su lui
hai prevalso con suo grave pericolo,
se non rischio mortale addirittura.
Ma sarà quel che sarà.
(Ho detto che sono parole dolenti, queste, parole d’angoscia, words of agony, ma, a quel che mi risulta, nessun critico le cita come tali. Mi sento, a questo punto,in svantaggio, per il fatto che non ho mai assistito a una rappresentazione del Coriolano. Ma trovo, leggendo questo brano, o piuttosto immaginandolo recitato (da questo o quell’attore: da Laurence Olivier, in ispecie, o dal giovane Marlon Brando) che esso impiega molto tempo ad arrivare al dunque. Ciò dipende fra l’altro dal fatto che vi sono parecchie ripetizioni. Ma c’è anche di mezzo, ne sono sicuro, lamia incertezza riguardo alla durata delle pause (dei silenzi) che il recitante osserva, sia prima sia durante questa “tirata”— una tirata che si può pure intendere che esprima il “silenzio” con cui il figlio tiene stretta la mano della madre, e poi la molla. Proviamo a immaginare, allora, che Coriolano molli la mano di Volumnia solo prima di pronunciare l’ultima frase del brano: “But let it come” [alla lettera: Ma lascia che venga, Ma avvenga pure; il Ferrando traduce: Ma ben venga. A noi sembra che il senso logico di questa interiezione, considerato il resto della battuta, sia piuttosto generico: Sarà quel che sarà… NdT] come se ciò che deve “venire” sia esattamente espressivo del loro separarsi, o, diciamo, del separarsi di Roma da Roma. Allora, possiamo immaginare che Coriolano si vada mentalmente raffigurando che cosa sia, ciò che sta per accadere (che “sarà”) e quindi ci chiediamo: quanto tempo impiega a immaginarselo, prima di pronunciare la frase: But let it come, Ma ben venga, Ma avvenga ciò che vuole, Ma sarà quel che sarà?) Che cosa significa poi che Volumnia potrebbe essere stata “most mortal” [alla lettera: micidialissima, mortale al massimo] per Coriolano? [Una traduzione interlineare dell’intera frase, Most dangerously you have with him prevailed / if not most mortal to him, sarebbe: Molto pericolosamente tu hai su lui prevalso / se non molto mortale per lui. Il Ferrando traduce: “tu hai prevalso su di lui con suo grande pericolo, se non pure in maniera mortale.”] Certo non si può pensare che Coriolano alluda all’eventualità della sua morte in combattimento—il che non spaventa affatto un simile uomo. Egli deve perciò voler dire, più o meno: Tu hai fatto sì che io potessi incontrare la morte sbagliata, una morte inutile, infruttuosa. Lo ha fatto, Volumnia, dimostrandogli che lui (Coriolano) nutre dei sentimenti? Ma in genere si ritiene che Cristo li avesse,dei sentimenti umani. Lo ritengono anche coloro che credono nella sua natura divina. La battuta di Coriolano esprime la sua dolente, angosciosa (agonized) sensazione che sua madre non sappia chi è lui, e contiene altresì un’accorata (agonized) implorazione: ch’ella gli creda. Ella (nella fantasia di lui) lo ha privato del cielo, gli ha negato [vietato] di sedere accanto al padre, per il fatto di avergli negato la fiducia, di non aver avuto fede in lui, dal momento che – s’ella non crede che lui è un dio, ebbene, probabilmente lui un dio non è, e, certamente, niente di simile allo scenario cristiano potrà verificarsi, poiché – per esso – la fiducia (la fede) della madre è indispensabile. Se fosse suo padre a sacrificarlo per la città degli uomini, allora sì, lui potrebbe essere un dio. Ma se, a sacrificarlo, è la madre, lui un dio non è. La logica, nonché la psicologia, della sua situazione è che egli non può sacrificare sé stesso. Egli può procacciare cibo spirituale ma non può “farsi” cibo, non può dire, mettiamo: Questo pane è il mio corpo. Il suo sacrifico non sarà salvifico (redemptive) quindi possiamo dire che la sua tragedia è ch’egli non può raggiungere, realizzare (achieve) la tragedia. Egli muore in un luogo estraneo, non pertinente (irrelevant) al suo sacrificio, trafitto da molte spade, da parte di uomini che non possono, da lui, trarre alcun nutrimento. È troppo presto, nella storia del mondo romano, per il sacrificio cui egli aspira e dal quale si tira indietro.
E forse è troppo tardi, come se il dramma fosse tra due mondi. So di essere stato colpito dall’evidente incorporazione, nel Coriolano, di alcuni elementi delle Baccanti di Euripide, senza sapere se sia o no pensa- bile un nesso storico. In particolare ad influenzarmi è stata la sensazione che l’invocazione di Coriolano a Volumnia, nel quinto atto, risenta dell’invocazione che Penteo rivolge a sua madre, Agave, alle porte di Tebe,affinché ella riconosca in lui il figlio e non lo faccia a brani. Il tema delle Baccanti è l’introduzione di un nuovo culto, quello di un dio, Dioniso, che – al pari di Demetra con il grano – arreca con il vino nutrimento all’umanità, un dio che esige “riconoscimento” al fine di glorificare sua madre, Semele, e proclamare ch’egli è figlio di Zeus. I primi, a Tebe, a riconoscere tale discendenza sono due vecchi. La mia idea è che Coriolano incorpori sia l’implacabile Dioniso sia il rabbioso incostante Penteo; e che Volumnia incorpori sia la casta Semele sedotta da un dio, sia la folle e micidiale Agave. Volumnia identifica sé stessa con Giunone (specificamente, con l’ira di Giunone) e ciò induce a credere ch’essa avverta sé stessa come causa della propria maledizione. Non è essenziale, ai miei fini, stabilire che Shakespeare conoscesse le Baccanti di Euripide; basta tener presente ch’egli conosceva il racconto che Ovidio fa, di Penteo, nel Libro III delle Metamorfosi, e supporre che abbia inteso questa storia, al pari di Euripide, come la storia di un figlio (incapace di esprimere desiderii) al quale il mancato “riconoscimento” da parte della madre si presenta come la “sensazione” di esser fatto a brani.
Cos’ha di buono una tale tragedia di tragedia mancata? Vale a dire: cosa rappresenta per noi questo dramma? In che modo esso deve operare? Ecco dove volevo arrivare. E ora che l’interrogativo è stato posto, posso solo esporre, recisamente, senza entrare in tanti dettagli, quelle che sono le mie (provvisorie) conclusioni al riguardo. Le traggo da certe considerazioni relative all’apologo di Menenio Agrippa, la cosidetta Favola del Ventre, da lui narrata nella scena iniziale del Coriolano. Il fatto che essa si collochi in luogo così preminente deve avere una ragione ben precisa. Fino a qualche tempo fa, la maggior parte dei critici ritenevano che Menenio desse voce ad un concetto che all’epoca di Shakespeare era un luogo comune e che, quindi, l’apologo esprimesse l’idea che, dello Stato, aveva lo stesso Shakespeare: come di un’organizzazione gerarchica avente analogia con un sano e ben funzionante organismo umano. È mia impressione che critici più recenti tendano a non dar tanto peso all’apologo, come se la sua morale conservatrice sia l’unica morale possibile, e, pertanto, non più accettabile, non più presentabile. Ma a me sembra che, in tal modo, si mettano in noncale i tre principali dati di fatto relativi al racconto di Menenio ed al modo in cui esso è messo in scena.
1) L’apologo riceve contrastanti interpretazioni. Menenio ed uno dei suoi interlocutori scherzosamente dissentono su chi sia meglio intendere come “ventre”, se la plebe o il patriziato.
2) L’apologo ha per tema il cibo, la sua distribuzione, la sua circolazione.
3) L’apologo viene raccontato (da un patrizio) ad alcuni popolani in procinto di insorgere contro il governo che, secondo loro, deliberatamente li affama, e che – dicono – dà loro parole anziché cibo. Il primo mistero della play è che ciò sembra funzionare, che bastano le parole – cioè – a fermare i rivoltosi, i quali si soffermano per ascoltare Menenio, come se fossero, appunto, in determinate circostanze, propensi a prendere per cibo le parole, a equare queste a quello.
Coriolano, sopraggiunto al termine della disputa, conferma l’equazione parole=cibo. Egli è stato già identificato, dai popolani, nelle prime battute della play, come loro principale nemico, addirittura come capo di coloro che rifiutano cibo al (affamano il) popolo; e Coriolano, nel discorso che rivolge ai popolani, dopo aver espresso disgusto per loro, afferma che, in effetti, egli rifiuta loro “buone parole” e seguiterà a rifiutargliele. Ogni parola ch’egli pronuncia, pertanto, significa rifiuto (withholding, alla lettere “ritenzione”) di buone parole. Egli avrà, per così dire, una spada nella bocca. Altre volte ricorre, nel Coriolano, l’equazione parole = cibo (per esempio si ribadisce il noto concetto che capire è digerire) ma a me basta questo esempio per ritenere, alla luce di mie precedenti asserzioni, che tale equazione rinvii alla principale figura della nostra civiltà, il Cristo, per il quale le parole sono cibo. La parola fatta carne deve essere mangiata, nell’eucarestia. Inoltre, le parabole di Gesù vertono soprattutto sul cibo, e sono sempre intese come nutrimento. L’equazione parole=cibo ci induce a tornare sui due discorsi cosiddetti “di intercessione” che Volumnia rivolge a suo figlio, non tanto per il loro contenuto, quanto per il fatto che essi sono i discorsi più lunghi cui Coriolano presta ascolto, che in essi Volumnia mette a nudo il suo cuore e che ad essi Coriolano oppone un tenace silenzio: diresti che egli venga “riempito”, saziato, dalle parole della madre. Mi piace qui rammentare che anche l’Apocalisse contiene una visione di parole che vengono mangiate: c’è un libro che lo Scrittore inghiotte ed è al palato dolce come miele, ma amaro nello stomaco (10:10 — Et accepi librum de manu angeli, et devoravi illum: et erat in ore meo dulce tamquam mel, et cum devorassem eum, amaricatus est venter meus) come se la bellezza fosse l’inizio del terrore, come, per esempio, in una play di Shakespeare.
La mia conclusione circa il funzionamento (working, modus operandi) del Coriolano, riguardo alla precipua caratteristica di questa play, può riassumersi nel modo seguente. Io considero il racconto della Favola del Ventre come una sorta di play-nella-play, una dimostrazione di ciò che Shakespeare intende che la suaplay (intitolata a Coriolano) sia, dappoiché anche il Coriolano è una favola sul cibo, con contrastanti interpretazioni che vanno “applicate”, un apologo narrato da un uomo ad un gruppo di persone (ad un pubblico, diciamo) invitate a soffermarsi, a tralasciare per il momento faccende più pressanti, al fine di ascoltarlo. Qui sta la rilevanza che io scorgo nel fatto che il Coriolano fu scritto in un periodo di carestia e di insurrezioni. Questo dramma mette in discussione, oltretutto, la questione dell’autorità e l’opportunità di metter in scena “l’attualità”, ossia rappresentare, in un dato periodo della storia inglese, un analogo periodo nella storia dell’antica Roma, ad usum dei contemporanei di Shakespeare. Vedo nella riproposta da parte di Shakespeare dell’apologo di Menenio Agrippa una entrata-incompetizione (o in polemica) con Sir Philip Sidney, il quale, nella sua Defence of Poetry (Difesa della Poesia) citava appunto la Favola del Ventre. Scrive il Sidney che il racconto dell’apologo di Menenio “causò un tale effetto sul popolo, quale mai io non lessi che semplici parole di per sé causassero, determinando un sì improvviso e sì opportuno mutamento; poiché ad esse, infatti, a ragionevoli condizioni, una perfetta riconciliazione tenne dietro.” Introducendo Menenio come personaggio del Coriolano e affidandogli il racconto dell’apologo proprio nel primo atto (allorquando gli spettatori possiedono scarse informazioni o scarsa esperienza per poterne giudicare gli eventi) lo Shakespeare mette in questione sia il “mutamento” sia la “perfezione” della riconciliazione dati invece per scontati dal Sidney. E poiché questi sono i due principali elementi su cui poggia la Difesa della Poesia del Sidney, tale difesa viene, come tale, messa in discussione. Ma, dal momento che, cionondimeno, Shakespeare fornisce la propria versione del racconto dell’apologo, e dice la sua in merito alla distribuzione delle risorse annonarie (del cibo) ecco che si può quindi argomentare che Shakespeare perori, in questa stessa play, la sua Difesa della Poesia (più particolarmente, della poesia drammatica, cioè delle opere di teatro, plays, che il Sidney particolarmente attacca). Alla luce di ciò, val la pena di notare che il Sidney considera la poesia “eroica” quella che maggiormente “scoraggia tutti i maldicenti” e che “non solo insegna e commuove ad una verità, ma insegna e commuove alla più alta ed eccellente verità”. Ma siccome “l’immagine di tali valorosi” quali la “poesia eroica” li presenta, “infiamma la mente e le infonde il desio di emularli”, e siccome il Coriolano è un’opera che verte sul male che siffatta “infiammazione” produce, ecco che la play di Shakespeare precisamente mette in forse le ragioni su cui poggia l’asserzione del Sidney secondo cui “la Poesia Eroica è il migliore ed il più adeguato (accomplished) genere di Poesia.”
In che consisterebbe la difesa della poesia, in questa play? Cioè: in che modo essa ci invita a prendere in esame la questione? Ritengo che, mediante l’Apologoin essa incorporato, l’Autore intende identificare noi spettatori come “affamati” (starvers) e identificare le parole del dramma come “cibo” che l’uditorio deve “incorporare”. Allora dobbiamo chiedere a noi stessi, come dobbiamo chiedere ai cittadini romani: Perché ci siamo/vi siete soffermati ad ascoltare? Cioè: che significa far parte di questo uditorio? Sentiamo forse che queste parole hanno il potere di redimerci? Un potere salvifico per noi?
Esse [le parole] fanno parte della messinscena di una play di sacrificio; o meglio, visto come si mettono qui le cose, di un sacrificio mancato. E un festino sacrificale – vuoi in termini cristiani o precristiani, vuoi nietzschiani o freudiani – è qualcosa che si ricollega alla fondazione e alla preservazione di una comunità. Una comunità viene in tal modo identificata come “coloro che fanno parte (partake) del medesimo corpo, coloro che prendono una porzione (partake) di una comune vittima”. [In inglese to partake vale tanto “partecipare” quanto “prendere una porzione (di cibo)”. In italiano si potrebbe anche giocare su una falsa etimologia comune di “vitto” e “vittima” NdT.] Ciò assimilerebbe Coriolano al nostro esser presi in un cerchio di reciproco partaking, gli uni incorporando gli altri. E ciò è simboleggiato, o esemplato, dal parlare la medesima lingua. Una persuasiva ragione per cui Coriolano “sputa fuori” parole è, esattamente, che esse sono parole, che esse esistono soltanto in una lingua, e che una lingua è, metaforicamente, qualcosa che si condivide, sì che parlare è prendere nella, e dare dalla, tua bocca la stessa sostanza (matter = anche argomento) che gli altri danno dalla, e prendono nella, loro.
Per Coriolano non ha importanza (è esasperatamente irrilevante) quale partito il ventre rappresenti. Ciò che a luiimporta è che – chiunque sia a governare – tutti siano membri, che tutti partecipino alla stessa circolazione, allo stesso sistema di scambi, chiamiamolo qui Roma; è insomma importante che per procacciare nutrimento civile, tu acconsenta a che di te si prenda parte (be parteken of) e cioè: che di te gli altri si cibino. Il Coriolano non è una play di argomento politico, se con ciò si intende relativa a conflitti politici, a questioni, mettiamo, di legittima successione odi scelta di campo. La play tratta piuttosto della formazione del politico, della fondazione della città, tratta di che cosa sia che rende un animale razionale adatto alla conversazione, al civismo. Quest’opera teatrale sembra insomma pensare alla creazione della res publica come al superamento del narcisismo, dell’incestuosità e del cannibalismo; quasi che essa percepisse una identità fra questi rapporti (relations).
Nel costruire – e contendere con – un protagonista per il quale la circolazione del linguaggio è un’espressione dicannibalismo, il Coriolano assume il cannibalismo come simbolico della più umana delle attività, la più distintiva, o la più distinta [distinguished, nel senso di insigne, raffinata, o, in accezione arcaica, prediletta] delle attività umane. (Il Sidney cita la ben nota accoppiata:“l’oratio, dopo la ratio, è il maggiore dei doni largiti all’umanità.”) Coriolano desidera parlare, usare le parole, comunicare, senza scambiare parole; senza, diciamo, ragionare (con altri); parlare senza conversare, senza prender parte alla conversazione. È alla conversazione che Coriolano è inadatto, inetto, diciamo pure al discorso civile. Perciò io concepisco il Coriolano come un’opera che incorpora l’interpretazione che il Montaigne dà del “cannibalismo preso in senso letterale” come di qualcosa che è più civile delle nostre più sofisticate – soprattutto, più pervasive maniere di tortura psicologica, del nostro “divorare vivi” gli altri (9).
Interpretazioni politiche del Coriolano di Shakespeare saggio di Montaigne “Sui cannibali” è più specificamente pertinente a questa play: vi si racconta di un cannibale che, fatto prigioniero da una tribù avversaria di cannibali, li schernisce arditamente, rammentando loro che, quando in precedenti battaglie li aveva sconfitti, egli aveva catturato e mangiato i loro antenati, imodoché, cibandosi adesso di lui, essi si ciberanno della loro stessa carne – ed è virtualmente su questo stesso tono che Coriolano si rivolge ai Volsci quando si rimette alla loro mercè. Non basta: il saggio del Montaigne interpreta altresì il cannibalismo come un atto di vendetta; e racconta (con quella sua vena di misurata ilarità) che quando tre antropofagi visitarono Rouen e fu loro chiesto cosa trovassero di “più stupefacente”negli usi e costumi dei francesi del Cinquecento ecco una delle loro risposte, che mi limito a citare, senza fare alcun commento.
In secondo luogo (usan essi, nella loro lingua, parlar degli
uomini come di “una metà” gli uni degli altri) essi avevan notato
che vi erano, fra di noi, uomini ben pasciuti e ben forniti d’ogni
bendiddio, e che le loro altre metà erano invece mendicanti
che bussavano alla loro porta, emaciati dalla fame e poveri in
canna; ed essi trovavano strano, soggiunsero, che codeste bisognose
metà tollerassero una tale ingiustizia, e non scannassero
quegli altri, o non dessero fuoco alle loro case.
Nell’ambito di una tale concezione della circolazione del linguaggio, una domanda, non facile a formularsi, puòreclamare di venir espressa: Fino che a che punto può Coriolano (e la play che lo crea e che non lui contende) ritenersi capace di vedere la propria salvazione nel silenzio? Il tema del silenzio ricorre ossessivamente nel Coriolano. Per esempio, un compito che Coriolano, pur detestandolo, deve svolgere è quello di chiedere “voci” [voices, che in inglese corrente è sinonimo di votes, voti, suffragi, mentre in italiano voce=voto è un’accezione obsoleta, di cui si coglie un’eco nell’espressione “aver voce in capitolo” NdT] agli elettori, le cui “voci” egli non vuole assolutamente udire. Inoltre, le parole “silente” e “silenzio” sono magnificamente e misteriosamente associate con le due donne della sua vita. Alla moglie egli dice: “My gracious silence, hail! Salve, mio grazioso silenzio!” e della madre è detto, in una didascalia, che “He holds her by the hand, silent – Egli la tiene per la mano, silenziosa.” [E non quindi “silenziosamente” come alcuni traducono – ch’è oltretutto una contraddizione, poiché egli le sta parlando.] Nei riguardi di entrambe, moglie e madre, l’allusione al silenzio è espressione di intimità e di immedesimazione: nel caso della moglie sta a significare riconoscimento, libertà dalle parole, ma pur sempre in una vita aldilà del sociale (beyond the social) mentre nel caso della madre silenzio è sinonimo di diniego, di rifiuto (avoidance da avoid, evitare) di morte, e significa altresì che non c’è vita aldilà del sociale. Le ambiguità qui si inculcano nell’azione del dramma mediante le ripetute invocazioni di “Pace! Pace!”: isteriche inefficaci grida, in cui echeggia una parola che vale “silenzio!” in inglese. La play prende alla lettera questa tradizionale invocazione al silenzio [in inglese to hold one’speace significa idiomaticamente “mantenere il silenzio, star zitti” NcT] sottintendendo che il parlare è guerra, come se questa fosse la ragione per cui tanto le parole quanto la guerra possono servire da cibo. Ma il guerriero, l’uomo della guerra, l’uomo per la guerra, non può trovare pace nella pace—non soltanto perché, personalmente, non può avere una lingua civile nella bocca, ma anche perché una lingua è intrinsecamente incivile. Il silenzio non è assenza di linguaggio: non v’è siffatta assenza, per gli esseri umani; a tale riguardo, non c’è alcun mondo altrove.
Coriolano non riesce a immaginare, o non può accettare, che vi sia un modo per cui ci si possa incorporare a vicenda, per cui gli uni possano prendere parte (partake che, ricordiamo, vale anche “prendere una porzione”) degli altri, il che è viceversa necessario perla formazione e non già per l’estinzione di una comunità. (Così come non può immaginare di essere nutrito senza essere meritevole. Questo è l’esatto inverso della concezione del Cristo, per cui noi non possiamo di per noi [in italiano arcaico valeva “da soli”, cfr Machiavelli] meritare sostentamento, ed è per questa ragione, è in questo spirito, che dobbiamo chiederlo. Pertanto è la misantropia, come la filantropia, una certa parodia del cristianesimo.) Il Coriolano ci chiede di provare a immaginarlo, immaginare una benefica, reciproca consumazione, argomentando in sostanza che è in questo che la formazione di un uditorio (di un pubblico) consiste. (Come se vorare fosse contiguo a orare.)
A me sembra che ciò che sono venuto dicendo stia a dimostrare, in modo indubbiamente alquanto comico, che è vera l’ipotesi secondo la quale la tragedia ha origine da riti religiosi. Alquanto comico, dico, poiché deve sembrare ch’io abbia sgonfiato il problema, sottintendendo che l’ipotesi stessa è vera o non vera a seconda di cosa di intende per “tragedia”, cosa per “origine” e a seconda di quale “rito” si abbia in mente (10).
In effetti, io sostengo che se si accetta che le parole sono cibo, se si accetta che la figura centrale [del oriolano] evoca la figura centrale dell’Eucarestia, allora si può pure accettare una formulazione secondo la quale la play (lungi dall’essere il rito dell’Eucarestia) celebra, o aspira a celebrare, lo stesso fatto che il rito celebra: diciamo, la condizione di comunità, lo status di comunità. Eucarestia significa etimologicamente “riconoscenza, gratitudine”, e Coriolano ritiene che il popolo romano gli neghi, appunto, gratitudine. È anche per questo che a me non basta dire che Coriolano è adirato, in primo luogo, a causa della codardia del popolo. Forse, si potrebbe dire che, per Coriolano, codardia equivale a ingratitudine. Quanto al concetto di “origine”, basta far riferimento al concetto di Cartesio, per cui l’origine di una cosa è la stessa cosa chela preserva. Ciò che preserva una tragedia, ciò che crea l’effetto di un certo tipo di dramma, è l’appropriazione da parte di un pubblico di questo effetto, la nostra mutua incorporazione delle parole di esso. Quando la condivisione di un sacrificio ha luogo su terreno religioso, il rito stesso ne assicura l’efficacia. Allorché la si trasferisce su terreno estetico – in un teatro –non v’è siffatta preesistente assicurazione; l’opera d’arte deve cavarsela da sé, sbrigare essa stessa ogni cosa. Potreste pensare che questa sia la rinascita della religione dallo spirito della tragedia. Una rappresentazione scenica non è nulla senza la nostra partecipazione, in seno a un uditorio; e tale partecipazione dipende da ciascuno di noi.
È per imporre la necessità di tale decisione (decisione imposta, analogamente, anche al singolo lettore che prende inmano il copione) che, secondo me, le parole di questa play sono così spoglie, aspre, severe [stark ingloba questi tre significati] e relativamente ineloquenti, mancando di evidente risonanza. Questa play ci mette di fronte al nostro bisogno di scambievoli parole, presentandoci il rifiuto, la ritenzione, delle parole, usando cioè parole che si negano, che non ci vengono incontro a metà strada. Insomma questa play ci presenta una fame di parole. Questo modo di intendere il Coriolano vede in esso il compiersi di una profezia biblica: “Ecce dies veniunt, dicit Dominus: et mittam famem in terram; non famem panis, nec sitim aquae, sed audiendum verbum Domini. – Manderò la fame sulla terra,non fame di pane, né sete di acqua, bensì fame e sete d’udire le parole del Signore.” (Libro di Amos, 8:11)
POSTSCRIPTUM
Si riterrà, dovrebbe ritenersi, che la mia lettura di un Coriolano disgustato dal linguaggio ha dovuto tenersi studiosamente alla larga da una interpretazione più ovvia, o altrettanto ovvia, ancorché meno esplicita, di codesto disgusto. Ho detto ch’egli ha orrore di mettersi in bocca ciò che (nella sua fantasia) esce dalla bocca di altri, e ho soggiunto che è questo il motivo per cui a Coriolano non importa che nell’Apologo di Agrippa siano i patrizi oppure i plebei a “essere” il ventre, o la lingua o qualsiasi altra parte del corpo. Ad allarmarlo è semplicemente l’idea di essere (lui) un qualsivoglia membro, insieme ad altri, dello stesso organismo. V’è però un altro modo di intendere la ragione di tale suo allarme, una differente maniera di intendere l’Apologo. Questa maniera presuppone che l’Apologo venga preso alla lettera. Che esso non verta semplicemente(o soprattutto) su una certa ambiguità (chi s’intende che sia il ventre? chi fornisce il cibo a chi?) bensì su un’altra ambiguità (qual è il prodotto che il ventre fornisce? a cosa c’è da provvedere?) insite entrambe in tale concezione “organica” della res publica. Questa seconda ambiguità concerne la direzione che si immagina che “prenda” ciò che il ventre produce. Si dirige tale “prodotto” verso l’interno del corpo [sotto forma di energia, di calorie] oppure verso l’esterno, verso la comune madre terra [sotto forma di concime]? In questo secondo caso, il disgusto di Coriolano sarebbe dovuto al fatto che, incorporandoci a vicenda, noi incorporiamo le feci altrui, le scorie cioè di ciò che era già stato incorporato.
Se si dà questa lettura, due caratteristiche dell’Apologo trovano una collocazione migliore di quella che gli ho dato dianzi, concentrandomi sull’equazione parole= cibo. Rileggiamo la scena iniziale del Coriolano. Il Primo Cittadino dice a un certo punto: “…il ventre è la sentina del corpo” (a.I sc.1) cioè ne è la fogna, il pozzo nero. Menenio Agrippa, nel riferire la risposta che il Ventre dà alle altre parti del corpo che lo contestano, dice che esso (il Ventre) rivolge loro “un certo qual sorriso / che non veniva certo dai polmoni…” Non pretendo che voi pensiate che Menenio dice “sorriso” ma intende piuttosto una sorta di risata, o qualcos’altro di ugualmente “rumoroso”, ma dico soltanto che se vi accadesse di figurarvi un “rumorino” del genere, sareste incerti circa la provenienza di esso e potreste domandarvi: esce dall’alto [dalla bocca] oppure dal basso?
La direzione verso l’esterno della circolazione era (all’epoca di Shakespeare) tanto familiare quanto quella verso l’interno. In Antonio e Cleopatra, Antonio dice all’inizio: “I regni sono argilla: la terra concimata dal letame nutre la bestia come nutre l’uomo…” e verso la fine Cleopatra dice: “E grande è compiere la cosa che pone fine a tutti gli altri atti, che blocca ogni accidente e arresta l’incessante mutamento, che dorme e più non ciba quello sterco onde si nutre il mendicante e Cesare.” [Il testo inglese citato dall’Autore dice: “…and never palates more the dung / The beggar’s nurse and Caesar’s” (il verbo inglese to palate è tanto arcaico quanto lo è in italiano la forma transitiva di “cibare”). Una traduzione italiana che ho sott’occhio traduce“dung” (letame, sterco) con “fango”. Ma è interessante notare che alcuni filologi preferiscono una diversa lezione del brano scespiriano, in cui al posto di “dung” di legga “dug” (capezzolo, mammella) il che consonerebbe meglio con “nurse” (nutrice, balia) del verso successivo. Per cui il controverso brano dovrebbe tradursi: “…e dorme e più non assapora la mammella che è nutrice sia del mendicante sia di Cesare.” Il soggetto grammaticale di “dorme/sleeps” è “the thing/la cosa”, vale a dire la morte. Alcuni traduttori, come Aurelio Zanco con l’imprimatur del Praz, preferiscono appianare la sintassi e interpretare così: “[la cosa] che addormenta (anziché che dorme) e impedisce così di assaporare il fango.” NdT]
Tale immagine della terra nutrice dei suoi abitanti, omologa all’immagine della terra nutrita dagli escrementi di coloro ch’essa nutre (esseri umani inclusi), è – in entrambi i casi qui citati – un’immagine che scaturisce da una mente esaltata ed è, pertanto, riduttiva nei confronti dell’ambiente naturale: essa scaturisce infatti da stati d’animo (di Antonio e Cleopatra) che cercano una trascendenza nel comune destino del genere umano. Ciò peraltro significa che né Cleopatra né Antonio intendono negare – come invece nega Coriolano, poiché è sua missione negarlo – che questa circolazione [circolarità] è comune, è addirittura ciò che è comune, a tutti i gradini della scala degli esseri viventi. Secondo me, le tarde opere scespiriane di ambiente romano si collocano su questo asse (exist on this axis) secondo quella che Norman Rabkin chiama “relazione di complementarità”. Ne consegue che alle due direzioni della circolazione del nutrimento viene impedito – in più sane immaginazioni, in più sani appetiti – di incrociarsi; che l’immaginazione di ciò che la bocca riceve come cibo viene normalmente mediata facendola passare attraverso la natura (is normally mediated by passing it through nature) in modo da purificare il contributo dato al processo da altri (diciamo) esseri umani.
Nel congetturare che in Coriolano l’immaginazione sia collassata su sé stessa, e che quindi Coriolano fantasizzi che alui venga imposto di nutrirsi direttamente degli escrementi altrui, io non ritratto quanto già affermato riguardo al disgusto ch’egli prova per le parole che escono dalle altrui bocche, bensì vi aggiungo un’ulteriore glossa, glossando che cos’è ch’egli pensa che le parole siano, e che il cibo sia, o, possiamo dire, che la “catena del cibo” sia. Mantenere il proprio equilibrio critico in questa materia, non consentire alla propria immaginazione di collassare su sé stessa, non potrebbe essere più difficoltoso (trickier). La stessa allusione all’elemento che questo postscriptum invoca potrebbe, di per sé, soffocare ciò che il mio saggio, nelle pagine precedenti, ritiene – correttamente, persisto a pensare – essere fondamentale nel Coriolano: vale a dire la circolazione del linguaggio di bocca in bocca. Il trucco consiste nel lasciare che questo dato di fatto venga contestato, e non già rovesciato, dalla congettura che il linguaggio sia al tempo stesso qualcosa che viene trattenuto, il che fors’anche significa accumulato (hoarded: accaparrato, tesaurizzato), per essere espulso, o bandito, ch’è un modo di concepire la scrittura come qualcosa capace di cambiare, fisicamente, il mondo.
Questa congettura si evidenzia, nelle parti del mondo da me conosciute, soprattutto nello slang o nelle facezie, come quando E.E Cummings fa dire al suo Buffalo Bill: “There is some s. I will not eat, — C’è un po’di m. Non ne mangio,” oppure in espressioni che rifiutano le parole altrui, nominando gli escrementi del toro [allusione a un’espressione idiomatica dell’inglese in cui bull-shit, merda di toro, sta per “fandonia”, quindi “don’t give me any bull-shit” vuol dire “non contarmi fregnacce” NdT]. Eppoi questo concetto presenta un nesso con concetti che associano la circolazione del cibo alla circolazione del denaro (vedi nota 10). Qui ilnesso si instaura tramite il significato di “superfluity” (superfluità, eccesso, sovrabbondanza) come quando il Primo Cittadino, nella prima scena del primo atto, dice: “Quello di cui l’autorità (=la classe dirigente) si rimpinza, a noi darebbe sollievo. Se essi ci cedessero soltanto il superfluo, purché non ancora avariato, potremmo credere che ci aiutano per solidarietà umana. Senonché noi gli siamo troppo cari: la nostra penuria dà risalto alla loro abbondanza; i nostri patimenti son per loro un guadagno”. Inoltre il nesso fra “parole” e “danaro” tramite il “grano” è ribadito in un’altra lunga battuta dello stesso Primo Cittadino, susseguente all’entrata in scena di Menenio Agrippa: “Non son mai curati di noi, finora! Ci lascian crepare di fame e hanno i granai pieni zeppi. Fanno leggi sull’usura, che favoriscono gli usurai…” Secondo me, Shakespeare qui non accenna all’usura semplicemente come concausa (storicamente attestata) di un’altra precedente sommossa, ma anche per mettere le due sommosse, per così dire, in apposizione: in modo da fare di usura e accaparramento (quindi penuria) metafora l’una dell’altra. Senza insisterci su, voglio qui alludere al ripristino (rehabilitation) da parte di Marc Shell del concetto di “usura verbale” nel suo eccellente saggio sul Mercante di Venezia, concetto che secondo lui si collega “alla generazione di un illegale (i padri della chiesa dicono innaturale) supplemento del significato verbale mediante il ricorso a metodi quali il gioco di parole (punning) e l’adulazione” (11).
È come se Coriolano trovasse sempre e comunque “usurario” l’uso delle parole, mentre i cittadini lo accusano di una sorta di avarizia verbale, che priva loro di qualsiasi credito. Nelle battute dei Cittadini si avverte non soltanto la loro pena per i patimenti dovuti alla fame e alla miseria, ma anche per l’insopportabile significato di tale pena, la quale è indice del disprezzo che i patrizi nutrono per i plebei. (Dicendo che il grano è un nesso fra parole e denaro, do per scontato il nesso, su basi sia marxiste sia freudiane, fra denaro ed escrementi. Il carattere popolare di tale nesso è presente in una frase scherzosache ebbe a dirmi mio padre quand’ero studente, e che ha contribuito a rendermelo convincente: Hai messo a buon profitto lo studio della chimica, mi disse, poiché sei bravissimo a trasformare il denaro in dreck—parola jiddisch che vale “robaccia”, “porcheria” [ed è presente anche nel dialetto triestino]).
Per rispondere al quesito di Paul Alpers relativo al “senso del comico” che sottende la mia lettura del Coriolano, avrei dovuto tirare in ballo, oltre al “sorriso del ventre”, anche la “risata degli dèi”. Dove sta il buffo? Chi potrebbe riderne? Alcune parole di Freud ci posson essere di ausilio:
Ci sono anche altri mezzi atti a rendere comiche le cose, che meritano una speciale considerazione… La caricatura, la parodia e il travestimento (nonché la loro controparte pratica: lo smascheramento) sono dirette contropersone ed oggetti che reclamano autorità e rispetto, che sono in certo qual senso sublimi. Si tratta di procedure miranti alla degradazione: Herabsetzung è l’efficace espressione tedesca… Allorché le procedure poste in atto per degradare il sublime consentono che ci si faccia, di esso, un’idea tutt’altro che grandiosa, bensì lo si veda come qualcosa di ordinario, di banale, al cospetto del quale non si debba scattare sull’attenti, ma si possa tranquillamente restare “in riposo” – per usare una terminologia militaresca – ebbene, ci viene risparmiata la fatica e la “spesa aggiuntiva” del solenne ritegno… e tale scarto nella “spesa” può venir scaricato mediante il riso.
Sotto il titolo “smascheramento” possiamo anche includere […] il metodo atto a degradare la dignità di determinati individui volgendo l’attenzione sulle debolezze che essi hanno in comune con il resto dell’umanità, e, in particolare,sulla dipendenza delle loro funzioni mentali dai loro bisogni corporali. Lo smascheramento equivale qui ad un monito: il tale o il talaltro, ammirato come un semidio, è dopotutto umano come voi e me (12). Ma il piacere comico inerente alla scoperta dei punti deboli, delle “vulnerabilità”, di Coriolano per noi che non siamo né dèi né soltanto ventri, non va molto al di là della grama soddisfazione di una ironica consapevolezza delle imperfezioni della sua virtù, dell’inutilità della sua utilità. Ripenso alla mia congettura per cui la formazione di una società dipende dall’esservi – dal nostro ottenere – una compartecipazione reciproca, un partaking [prender parte ma anche “prendere porzioni”] gli uni degli altri, che sia benefico, creativo, non annichilente, come se il nostro reciproco cannibalismo fosse una parodia di ciò che potremmo essere, per cui ci prendiamo gioco di noi stessi e desideriamo trascendere ciò che non meriterebbe più di essere trasceso qualora noi potessimo, di comune accordo, rinunciare al suddetto desiderio (come se l’aver gli uni bisogno delle mani [hands] degli altri significasse che gli esseri umani sono fatalmente destinati ad accettare ciò che essi hanno finora appreso a consegnare [to hand] gli uni agli altri). Invece, ci sentiamo deprivati, quindi vendicativi, ci sentiamo fatalmente destinati, per come stanno le cose, a non ricevere un bene pari a quello che elargiamo. (La necessità comica insita in tali sentimenti e sensazioni, o tragiche contingenze, va individuata, per quanto riguarda la Favola del Ventre, nel fascino esercitato dal concetto di ‘corpo politico’come se il ventre sorridesse ad ogni teorizzazione che assi- mila lo Stato, o diciamo la Sovranità, a qualcosa di organico. E il pensiero politico è forse conscio di essere immune da tale fascino? Di essere estraneo al concetto dei due corpi, o forse più, del cittadino? O conviene pensare che ciascuno di noi è ‘di due o più menti, due o più stati d’animo’—stante la frase idiomatica inglese per cui to be of two minds significa “essere esitante”?)
Ho già detto, in altre parole, all’inizio di questo poscritto, che nel Coriolano l’analità è meno esplicita dell’oralità, eche, nelle pagine precedenti del mio saggio, mi sono limitato a parlare della sua “oralità”, sottintendendo che l’esser essa [l’analità] perlopiù implicita nelle parole della play non costituisce motivo sufficiente per lasciarla inesplicita, compiendo un ulteriore sforzo critico. Ma si può anche, come fa Kenneth Burke, ritenere che alla cosa sia data piena esplicità nella play, a cominciare dal nome stesso del protagonista eponimo. Nel suo magistrale saggio dal titolo “Coriolanus and the Delights of Faction” (Il Coriolano e i piaceri della faziosità, del dissenso) il Burke scrive:
Sebbene i nomi siano prelevati, pari pari, da Plutarco, è degno di nota quanto tonalmente suggestivi alcuni di essi siano, dal punto di vista del ruolo che certi personaggi svolgono in questa play inglese. […] Al lume delle teorie freudiane relative alla natura escrementizia dell’invettiva, le ultime due sillabe del nome del protagonista [e cioè anus, ano, poiché in inglese Coriolanus si divide così in sillabe: Cor-i-ol-an-us, NdT] sono talmente “giuste” (right), che molti oggi tentano, spesso, di eludere la questione alterando la tradizionale pronuncia di Coriolanus e rendendo breve anziché lunga la a di anus (13).
Ma in che modo dobbiamo specificare che cosa è “giusto” (right, esatto) riguardo al nome? Data per data la particolare attenzione rivolta al nome del protagonista nella play di Shakespeare, questi potrebbe aver voluto dare, intenzionalmente, al suffisso anus lo stesso suono che ha la parola che allude alla forma dello sfintere, appunto, anale – al fine, diresti, di attuare una sorta di giustizia poetica. (Un altro accenno a siffatta giustizia si può forse rilevare nel fatto che Burke suggerisce “eccesso” oltreché “orgoglio” come traduzione di hubris.) Il Burke usa molto tatto, nel trattare questo argomento, sia nel saggio citato sia altrove, ed io – sebbene nel corso di una conferenza, sullo stesso argomento del mio saggio, avrei magari alluso alla “questione fecale” come a qualcosa da potersi prendere in considerazione – non ho ritenuto conveniente prenderla in considerazione per iscritto. Quello che ho scritto mi sembrava infatti o troppo esplicito o troppo implicito, sfacciato o reticente. Posso in parte capire che la mia difficoltà sia inevitabile: uno non può disinvoltamente elevarsi al di sopra del livello del sense of humor della propria civiltà [Cioè: “comune senso dell’umorismo”ricalcato su “comune senso del pudore” NdT]. Come pure per quanto concerne altri argomenti, io mi servo di Walden [di Henry David Thoreau] a mo’di pietra di paragone anche per quanto concerne questa questione. Le frequenti allusioni che nel suo libro Thoreau fa al mangiare e al defecare sono espressione dell’enorme ammirazione ch’egli nutre per la capacità che hanno le sacre scritture (specialmente quelle indiane) di nominare gli organi del corpo e le loro funzioni come pure e semplici manifestazioni dei ritmi cosmici: dati di fatto e basta, senza invocare o eludere atteggiamenti nei loro confronti, come se supporli “buoni” o “cattivi” fosse presunzione. Thoreau ammira insomma chi ha la capacità di nominarli tranquillamente, e di fare raccomandazioni, al loro riguardo, con distacco: di nominarli filosoficamente. Al “nominare filosoficamente” potete pensare come a qualcosa cui la scrittura seria si tiene saldamente aggrappata. È proprio perché sono arrivato a vedere che il Coriolano di Shakespeare è esso stesso in lotta con tale questione dell’esplicitare e del nominare [del “pane al pane, pene al pene”] ovvero che essa [la questione] è insita nel modo in cui io propongo che il Coriolano vada inteso, come cioè uno studio del rifiuto delle voci e dei voti [talvolta sinonimi in inglese] onde il desiderio smodato di voci e voti, è proprio per questo, dico, che sono stato costretto dalla vergogna a (shamed into) rendere il mio imbarazzo più esplicito in questo poscritto. In ciò è implicito che evitare di rischiare il proprio equilibrio critico, nell’attraversare questa play, equivale ad evitare una più o meno convinta partecipazione alla valutazione che la play stessa dà di quell’equilibrio che la civiltà esige. Chiamiamola esazione di civismo (exaction of civility). Fino a che punto possono i poteri di una città reciprocare in civismo [ossia porsi su un piano di reciprocità con i cittadini in fatto di civismo] e restare poteri? Fino a che punto essi possono ricusare tale reciprocità senza dichiarare uno stato di guerra, intestina o esterna che sia? Spero di aver sufficientemente indicato, nel mio saggio, il motivo per cui uno studio di voci/voti sfocia in uno studio della formazione dell’umana società, del riconoscimento degli “altri” come “noialtri” o, per così dire, “miei altri” (my others). L’idea di un contratto sociale che esprima il consenso dei singoli a venir governati, ad essere civili, equivale a una richiesta,come ho avuto motivo di insistere, di chiarezza, di “esplicità” (explicitness), per arduo che sia stabilire che cosa si deve intendere per “esplicitezza originale” (original explicitness, a proposito della quale tengo presente il mio The Claim of Reason, pagg. 22-28). La si pensi nel modo seguente. L’acconsentire ad esser governati deve esprimere il desiderio di esser governati, governati per consenso, indi partecipare alla città, alla polis. Esprimere il desiderio in modo non esplicito è un atto di seduzione, quindi un atto che sussiste solo in un medium di proibizione e congiura,cospirazione. Può darsi che la vita sessuale umana continuerà a richiedere questo medium, e le relative lotte, nel prevedibile futuro, diciamo fintantoché la nostra politica non avrà creato un più perfetto medium sociale, infallibilmente intelligibile, reciprocante e nutriente. Senza di ciò, continueremo ad interpretare la privatezza (privacy) come inesplicità (inexplicitness) e quindi, su questo terreno, il privato continuerà ad esserenemico naturale del politico, come – in diversa, anzi opposta, maniera – è, a nostro rammarico, dimostrato, sia in Antonio e Cleopatra sia in Coriolano. A chi importa sapere se l’ingiusto può essere o no felice, dal momento che ancora non sappiamo se la richiesta di felicità è o non è sopravvivibile (survivable)? Inoltre, il concetto del riconoscimento degli altri come “miei” (concetto che sottintende il riconoscimento degli esseriumani come tali, cioè “umani”, come esseri che pensano) presuppone che si mettano insieme corpo e anima, che si connettano fra loro percezione e immaginazione, cosunque con queste parole si intenda. I filosofi hanno creato problemi, da par loro, in merito a “cos’è che è” [in che cosa consista] sapere che gli altri hanno una mente. Io, per me, ritengo che il Coriolano sollevi un’altra questione: cos’è che è [in che cosa consiste] sapere che gli altri hanno, che noi abbiamo, un corpo. Secondo la linea di pensiero seguita in questo postscriptum, bisogna sapere che, e magari sapere perché, il corpo ha (e del pari hanno i sensi) due aperture (openings) o due luoghi deputati ad aperture, le quali sono connesse fra loro, fatte l’una per l’altra, un’apertura superiore e una inferiore, oppure un’apertura anteriore e una posteriore, l’una verso l’esterno e l’altra verso l’interno. Ma qual è l’espressione di tale riconoscimento? Cos’è che lo riconosce? Cioè: qual è l’espressione di una cognizione del suo esser comune (its commonness) per esempio fra noi? Battere e ribattere su questa idea (come forse ci ribatteva Jonathan Swift) può far perdere il senso della sua comunanza, o ordinarietà. Ma come fai a sapere che restar zitto al riguardo non equivalga a negarla? Eppoi, l’insistenza metafisica di Cartesio sul fatto che noi siamo essenzialmente delle menti nega, forse, l’accidente universale che noi siamo (connessi a) corpi? E l’insistenza metafisica di Nietzsche sul fatto che noi siamo corpi nega, forse, la grandeur della mente? Se diciamo che portare il discorso sul nesso del corpo con sé stesso richiede tatto, possiamo anche dire che Coriolano ci fa sapere qual è il costo dell’assenza di tale tatto, di tale civismo. Pur mentre il suo caso è più estremo dei nostri, la soddisfazione che proviamo nello sbarazzarci di lui attesta che siamo da lui rappresentati, che di lui noi facciamo il nostro deputato, il nostro agente. Le differenze fra i nostri casi e il suo sono due: che noi esigiamo di meno dal nostro onore, che non lui dal suo; e che le divisioni sociali fra noi sono meno nette che non ai suoi tempi. Queste differenze denotano, tutt’al più, la nostra fortuna, o tardività (belatedness) [cioè il nostro esser venuti al mondo 25 secoli dopo] non già il nostro merito. Quindi ritengo che nessuno è in grado di dire quale sia la giusta espressione della nostra cognizione del fatto che siamo disposti in fila (strung out) su entrambi i lati di un ventre. Allora la questione che si pone è: dobbiamo o no sapere ciò prima di poter sapere quale compartecipazione (partaking) rende “buona” una città, oppure se la città, nella sua scarsezza di bontà, possa, o no, fornire a sé stessa degli individui, o gruppi, che sappiano questo, e se essa [la città] possa allora o non possa ascoltare cio che essi [i cittadini] hanno da dire, sia che essa possa o sia che essa non possa tollerare la voce del suo stesso linguaggio.
Traduzione di P. F. Paolini
NOTE
1 The Claim of Reason (New York e Oxford, 1979). L’argomento è stato affrontato in “The Avoidance of Love: A Reading of King Lear” in Must We Mean What We Say? Ristampa, Cambridge, Inghilterra, 1976.
2 V. Bertolt Brecht, Collected Plays, vol. 9, a cura di Ralph Manheim e John Willett (New York 1973) pagg. 378-94.
3 In Representing Shakespeare, a cura di Murray Schwartz e Coppelia Kahn (Baltimora, 1960)
4 “Sembra che ci si chieda: se il conoscere sé stesso di tizio sia qualcosa di attivo, qualcosa che tizio fa […] oppure sia qualcosa che tizio subisce, qualcosa che gli capita fra capo e collo…” (The Claim of Reason, pag. 352).
5 Un punto è, questo, posto in risalto dal presidente del “Coriolanus Panel” (Tavola Rotonda sul Coriolano) alle riunioni di Stanford, prof. Harry Berger, nel presentare il mio intervento.
6 V. saggio cit., nota 3.
7 Questa non intende essere un’alternativa a, bensì un’estensione della, bella intuizione di Philip Brockbank, il quale in una nota alla sc.9 del primo atto del Coriolano (ed. Arden) scrive: “Un nome viene trovato in questa scena e un altro va perduto”. Secondo me entrambi i nomi sono stati “imposti” a Caio Marzio. Sono stato influenzato, al riguardo, da un ulteriore cambiamento che Shakespeare apporta alla caratterizzazione che dell’uomo fa Plutarco. In Plutarco, Coriolano parla di quest’uomo come di “un mio vecchio amico e ospite”. Nel Coriolano invece Coriolano dice ch’egli ha dormito in casa di quell’uomo. Proprio all’inizio della Vita di Coriolano di Plutarco si legge: “La casa dei Marzii” e “casa” sta evidentemente per “famiglia”, frase che Shakespeare riporta alla fine dell’atto II, allorché i Tribuni chiedono a Coriolano “chi fur li maggior sui”, come se questo fosse ai loro occhi sufficiente merito per l’elezione a console, ma insufficiente agli occhi di Coriolano.
8 Il disgusto che Coriolano prova per i popolani viene esplicitato da Shakespeare, accennando al loro “cattivo odore”. Due volte Shakespeare usa il verbo to spit che significa tanto “sputare” quanto “schidionare, trafiggere”. Una volta per descrivere la fronte di Ettore sanguinante in battaglia; e un’altra volta nel monologo di Coriolano davanti alla casa di Aufidio: “…a meno che le loro donne con schidioni e i loro ragazzi con pietre […] non mi uccidano.” In entrambi i casi spitting si collega alla battaglia e al cibo.
9 Poiché trovo avvincente l’abbinamento “parole/cibo” ignoro qui il parallelo fra circolazione delle parole e circolazione del denaro. Per es.: “I miei polmoni / conieranno parole…” (a.III, sc.1) oppure: “Il prezzo è, chiederlo gentilmente…” (a.II, sc.3).
10 Nel corso del dibattito svoltosi alla Stanford, Paul Alpers ha detto che io sembro scorgere un’angolazione comica nel Coriolano anche laddove essa non è esplicita. E si è chiesto findove voglia io arrivare su questa strada. Trovo che questa sia una corretta reazione alla lettura che io do del Coriolano. Ma non posso qui ulteriormente dilungarmi in proposito.
11 “The Wether and the Ewe” in Money, Language and Thought di Marc Shell (Berkeley, 1982) pag. 49. Ho ingenti debiti con questo studioso. Shell ha preso parte al seminario nel corso del quale esposi per la prima volta le mie teorie critiche sul Coriolano. Ma solo in seguito ho letto tuti i saggi contenuti nel succitato libro ed il mio debito è aumentato. Il saggio intitolato “The Blank Check: Accounting for the Grail” mi suggerisce che la storia da me narrata, nel presente saggio, andrebbe ulteriormente estesa per includervi una menzione alla leggenda del Sacro Graal, là dove vi si parla di carestia e abbondanza. Cito qui alcuni brani del saggio di Marc Shell: Il dono infinitamente grande e il dono gratuito (nel senso che non prevede l’obbligo del contraccambio) possono ben essere impossibili negli scambi della vita quotidiana. […] L’ipotesi del dono infinitamente grande, per esempio, si manifesta come cornucopia, e l’ipotesi del dono gratuito (libero, free gift) come grazia paolina. […] Verso la fine del medioevo […] la prima largamente diffusa letteratura in volgare parla di un Graal “cornocupiesco”, un dono straordinario tanto infinitamente grande quanto gratuito, in grado – si diceva – di sollevare gli uomini al di sopra dell’ordinario mondo degli scambi ed immetterli in un mondo in cui libertà e totalità erano possibili. […]Le leggende del Graal parlano di una terra desolata (wasteland) in cui la sterminata (limitless) produzione di beni sia materiali sia spirituali rappresenta un limite definitorio e concettualmente senza pari (unique). (pag 24-25) Chrétien [de Troyes, 1130 circa- 1183] è un poeta- eminatore il quale prende in considerazione il rapporto della fertilità della sua sementa sia con la relativa sterilità del suo uditorio sia con la materiale sterilità della“terra desolata” di cui egli parla ad esso. La fertilità spirituale varia da persona a persona, talché Chrétien deve parlare, al tempo stesso, a diversi livelli. […] Tutti i racconti del Graal aspirano allo status di enigma, di indovinello (riddle) (pag. 25) Come il calamaio ricavato da un corno (cornu, in ingl. inkhorn) dell’apostolo […] la parola “graal” agisce nei racconti del Graal a mo’ di “cornucopia di parole” proprio come il Sacro Graal agisce a mo’ di una cornucopia di nutriente cibo. (pagg.26-27) All’inizio di Perceval ou Le conte du Graal di Chrétien de Troyes, per esempio, il protagonista Parsifal viene presentato come il tipico adolescente affamato che chiede cibo a sua madre, si aspetta di trovare del cibo in un padiglione che crede essere una cappella, chiede cibo al Dio ch’egli crede che abiti in quel padiglione- cappella, e alla fine riceve cibo terrestre. Solo il nutrimento divino, però, può soddisfare il desiderio di quest’uomo che “va alla ricerca” (questing man). Parsifal apprende quale sia il cibo che Dio provvede allorché un eremita, nel giorno di Venerdì Santo, gli dice che il cibo su cui egli ha omesso di chiedere [ragguagli] al castello del Graal era “reale”. (pag. 27) Quegli uomini che non hanno buon cibo da metter dentro le loro bocchie, non possono far sì che buone parole escano dalle loro bocche. (pag. 29)
12 Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio.
13 In Language as Symbolic Action (Berkeley e Los Angeles, 1966) pag. 96